|
 |
Altri articoli
|
 |
|
|
|

|
 |
Ecuador
|
 |
|
|
|

|
 |
Venezuela
|
 |
|
|
|

|
 |
Cuba
|
 |
|
|
|

|
 |
Colombia
|
 |
|
|
|

|
 |
Nicaragua
|
 |
|
|
|

|
 |
Brasile
|
 |
|
|
|

|
 |
Uruguay
|
 |
|
|
|

|
 |
Bolivia
|
 |
|
|
|

|
 |
Cile
|
 |
|
|
|

|
DISSENSO E POTERE: UN SECOLO DI LOTTE IN CINA
Incontro-dibattito

I temi ricorrenti e le dinamiche delle proteste e della repressione in Cina. Dagli inizi del '900 alla contemporaneità, uno sguardo sui movimenti studenteschi e di giovani intellettuali che animano la società civile cinese.

con Jeffrey Wasserstrom, Professore di Storia all'University of California, Irvine con specializzazione sulla Cina. In particolare si è particolarmente interessato alla protesta studentesca.
Antonio Fiori Professore associato Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Storia e istituzioni dell'Asia
coordina: Michelangelo Cocco - Giornalista, ex corrispondente da Pechino per il quotidiano "il manifesto". Fondatore di CINAFORUM portale d'informazione sulla prossima superpotenza.


Introduzione di Michelangelo Cocco


Intervento del Prof. Antonio Fiori (Italiano e inglese)



Intervento del Prof. Jeffrey Wasserstrom (Italiano e inglese)


Le domande del Pubblico
 

Traduzione: Alessandra Cappelletti

12 settembre 2015 al Centro Amilcar Cabral di Bologna
Il Ghetto Dietro Casa.
Kosovo: Storie di Visti (quasi) vissuti
Di Giovanni Bottari
 Mitrovica, Repubblica del Kosovo. Non troppo tempo fa. Mitrovica, Repubblica del Kosovo. Non troppo tempo fa.
Bevevo spesso caffè seduto ai tavolini del bar osservando quella moltitudine di persone che ogni sera invadeva il ‘boulevard’. Mi perdevo nei volti e ne immaginavo le storie. Lulzim era tra quelli. Più che la sua storia – una tra le tante, le troppe, in un mare di racconti inascoltati – a colpirmi fu il nostro incontro. Era una nottata alquanto movimentata: Trepça (la squadra di basket locale) aveva appena vinto il campionato. Entrai nel bar in cui ero solito andare per assaporare un po’ di quell’estasi collettiva. Lulzim faceva il cameriere. Era nervoso quella sera, l’espressione sul suo viso trasmetteva ciò che i movimenti nascondevano. Domandai un caffè e fu proprio lui a servirmi. Dopo aver preso l’ordinazione borbottò qualcosa in italiano. Erano settimane che non udivo parole familiari, a parte sporadiche telefonate con i miei genitori. La cosa mi fece sorridere nonostante ciò che avesse detto non si addicesse ad un cameriere. “Grazie” risposi. Lulzim rimase per un attimo perplesso, poi sorrise. Iniziò a domandarmi senza sosta il perché, come e quando fossi arrivato in città. Era su di giri, come fosse la prima volta che vedesse uno straniero. Mi supplicò di aspettare fino a che il turno di lavoro non fosse terminato. Non capitava spesso di incontrare italiani senza uniforme seduti a tavolini del bar.
Lulzim era un bravo ragazzo, glielo si leggeva in faccia: modi educati, gentile, amichevole. Aveva appena compiuto venticinque anni la sera che lo incontrai, gli ultimi dei quali ‘sprecati’ in quel bar che odiava più di una prigione. Ma così stavano le cose. Era cresciuto in una famiglia benestante, almeno questo prima della guerra. Suo padre e sua madre si erano conosciuti durante le grandi manifestazioni degli anni ’80. Lui figlio di un minatore ed una maestra di scuola elementare, lei proveniente da una famiglia fortemente religiosa. Il matrimonio fu stato uno dei pochi bei ricordi di quegli anni.
In quel preciso istante passò per strada un ragazzino a torso nudo con attorno al collo legata una bandiera raffigurante l’aquila albanese, nera su sfondo rosso. Se c’era una cosa che Lulzim odiava più di quel bar erano le bandiere che tappezzavano la città. Tutto quel sentimento nazionale, traboccante da ogni cosa, gli dava allo stomaco. Quella era la libertà per cui molti avevano combattuto e tanti erano morti: una bandiera. Come era misero l’uomo, che di così poco si accontentava e nei suoi simboli si crogiolava. Intanto loro vivevano a Mitrovica, la città del ponte, la città divisa, città dove i suoi stessi cittadini si erano dimenticati che forma avesse. Dove non si poteva attraversare il ponte per la paura poi di vedere che, alla fine, la città vista dall’altro lato del fiume non era così diversa. Vivevano in un paese dove non esisteva il diritto al lavoro, allo studio, ad un futuro degno del cimitero sul quale camminavano. Era stanco di tutto quello. Avrebbe voluto fare ciò che ogni ragazzo della sua età a Roma, Parigi o Berlino sognava: viaggiare, conoscere, innamorarsi.
Mi domandava continuamente dove fossi stato durante i miei viaggi, mi chiedeva di descrivergli minuziosamente i luoghi che avevo visitato come se anche lui potesse vederli. Gli si illuminavano gli occhi ogni qual volta usavo la parola ‘mondo’. Mi raccontò di quando era bambino: ogni settimana i suoi genitori lo portavano fuori città per la tradizionale gita domenicale. Posti che non riusciva a ricordare con esattezza ma che sembrava essere certo della loro bellezza. Ogni tanto qualche particolare gli tornava alla mente; pezzi di memoria che lo aiutavano a convincersi che non era sempre stato così, e ciò lo aiutava ad avere speranza che un giorno qualcosa sarebbe cambiato.
Poi venne la guerra e tutto diventò d’uno tratto più grigio e triste. Lulzim e la sua famiglia furono costretti a lasciare la città ed a rifugiarsi prima in un campo profughi in Albania e poi in Italia dove avrebbero passato i cinque anni seguenti. Fu lì che Lulzim imparò l’italiano.
S’innamorò dell’Italia, della sua storia, della sua cultura, delle sue genti, ed un giorno, aveva giurato, sarebbe tornato a farle visita. Portava sempre con sé un Pirandello o un Calvino che nei momenti di pausa lo aiutavano a scaricare i nervi e lo trasportavano in qualche luogo lontano. Presto, mi disse, avrebbe avuto i soldi necessari per andarsene, almeno per un po’. Avrebbe mandato a fare in c**o quello s*****o del suo datore di lavoro e si sarebbe imbarcato sul primo aereo diretto per l’Italia. Era questione di mesi.
Non andò esattamente così.
Rincontrai Lulzim qualche settimana dopo. Aveva una cera orribile e la vitalità che lo aveva caratterizzato sembrava essere sparita. Mi raccontò di essere andato al Consolato italiano a Pristhina per chiedere maggiori informazioni riguardò la richiesta per il visto. Ottenne due pagine in cui erano elencati tutti i documenti che ogni singolo uomo e donna residente in Kosovo doveva presentare per la richiesta. Mi fece vedere la lista. Lessi, in ordine: Passaporto (validità di almeno sei mesi), domanda per il visto interamente compilata (Allegato A), due fototessere, assicurazione sanitaria, certificato famigliare e di nascita, contratto di lavoro (se studente, certificazione che lo dichiari o equivalente lettera da parte dell’università), dichiarazione di reddito … [respiro profondo] … saldo bancario (movimenti e transazioni degli ultimi sei mesi), certificazione versamento contributi pensionistici (se lavoratore), autenticazione dell’avvenuto pagamento delle tasse, lettera o raccomandazione di un garante terzo residente nel paese di richiesta, somma minima di denaro (da definire), piano di viaggio. Per ogni documento bisognava presentare due copie al Consolato almeno sette giorni prima della prevista data di partenza. Ad ogni modo, la decisione ultima rimaneva a discrezione del corpo consolare in base alla documentazione fornita.
Il passaporto non era un problema, né i certificati o le assicurazioni – ovviamente per ogni singolo documento c’era da pagare una discreta somma di denaro che per un cameriere non erano cifre da poco. Il vero problema era che Lulzim lavorava in nero; non aveva mai pagato tasse né versato contributi. E di certo, pensare che il suo datore di lavoro lo avrebbe messo in regola una volta domandato era pura follia. C’era una fila di ragazzi pronti a lavorare per la metà dei soldi che Lulzim stesso guadagnava. Era disperato, non sarebbe mai riuscito ad ottenere tutti quei documenti. Mai.
2°Parte
Kosovska Mitrovica, Provincia Autonoma di Kosovo e Methodja. Più o meno stesso periodo, stessa città, solo aldilà del fiume ...
 Dusan era uno dei migliori studenti del suo corso: “semplicemente brillante” a detta dei suoi professori. Era al 4° anno di Medicina. Un ragazzo promettente, presto sarebbe partito per gli Stati Uniti con una borsa di studio. Era figlio di un ingegnere molto rispettato in città che per anni aveva lavorato nel quadro direttivo delle miniere Trepça, un genio che la guerra aveva trasformato in venditore ambulante. Aveva visto la Yugoslavia disgregarsi sotto i suoi occhi, cadere come un castello di carte. Era sempre stato contrario alla politica di apartheid portata avanti da Milosevic in Kosovo. Sapeva bene che continuando su quella strada presto la fratellanza e l’unità sarebbero cadute sotto i colpi dei Kalashnikov e sepolte nei cimiteri insieme a migliaia di persone. Dusan era uno dei migliori studenti del suo corso: “semplicemente brillante” a detta dei suoi professori. Era al 4° anno di Medicina. Un ragazzo promettente, presto sarebbe partito per gli Stati Uniti con una borsa di studio. Era figlio di un ingegnere molto rispettato in città che per anni aveva lavorato nel quadro direttivo delle miniere Trepça, un genio che la guerra aveva trasformato in venditore ambulante. Aveva visto la Yugoslavia disgregarsi sotto i suoi occhi, cadere come un castello di carte. Era sempre stato contrario alla politica di apartheid portata avanti da Milosevic in Kosovo. Sapeva bene che continuando su quella strada presto la fratellanza e l’unità sarebbero cadute sotto i colpi dei Kalashnikov e sepolte nei cimiteri insieme a migliaia di persone.
Suo padre gli aveva sempre insegnato a non giudicare mai un persona dal credo religioso, la lingua o ‘l’etnia’ d’appartenenza. Gli aveva sempre detto che le persone erano ciò che sceglievano di essere. Sembravano stupidaggini ma Dusan aveva un profondo rispetto per suo padre. Sua madre era morta durante la guerra, ‘danni collaterali’. Quando non studiava Dusan aiutava spesso sua padre. Era un uomo fantastico che nonostante la misera vita che era costretto a subire non aveva mai smesso di sorridere e di credere che le cose sarebbero andate meglio un giorno.
Non ricordava esattamente quando era stata l’ultima volta che aveva lasciato il Paese ma doveva essere stato molto tempo prima. Gli sarebbe piaciuto partire nuovamente, magari per le vacanze estive. Non voleva stare via troppo a lungo, gli studi non glielo avrebbero permesso e suo padre aveva bisogno di lui, ma una o due settimane di vacanze se le sarebbe potute concedere. L’Italia era da sempre stato il suo sogno. Non sarebbe dovuto essere difficile in fin dei conti.
Il Consiglio d’Europa nel Luglio del 2008 aveva finalmente votato a favore per la liberalizzazione dei visti nell’area dei Balcani Occidentali. La Serbia rientrava in uno dei paesi che avrebbero finalmente goduto di questo status. Da Gennaio dell’anno successivo tutti i cittadini serbi avevano iniziato a viaggiare liberamente (senza bisogno di visti) all’interno dell’area Schengen per un periodo non superiore ai tre mesi, oltre ai quali serviva il visto. C’era un ‘ma’ in tutta questa storia che Dusan a suo discapito avrebbe presto scoperto. Esisteva una discriminante: i ‘cittadini’ serbi residenti in Kosovo, differentemente dal resto dei loro concittadini, non godevano di tale libertà. Il documento redatto dalla Commissione Europea diceva: “ Dal 1999 la Serbia non ha avuto la possibilità di compiere alcuna verifica riguardante le persone residenti in Kosovo sotto la UNSCR 1244/99. […] la Commissione e gli esperti degli Stati membri non sono stati nella posizione di verificare l’emanazione di tali documenti (Passaporti Biometrici) e l’integrità e la sicurezza delle procedure seguite dalle autorità serbe per la verifica della correttezza dei dati presentati dalle persone residenti in Kosovo […]. Inoltre, in vista di preoccupazioni riguardanti la sicurezza, in particolare potenziale migrazione clandestina da parte di persone residenti in Kosovo o persone la quale cittadinanza è stata emanata per il territorio del Kosovo sotto la UNSCR 1244/99 […], la Commissione considera che i possessori di passaporti serbi emanati dal Coordination Directorate debbano essere esclusi dal regime di liberalizzazione dei visti per la Serbia”.
Ovviamente Dusan conobbe tutto ciò solo una volta arrivato a Belgrado. Avrebbe ottenuto il passaporto ma senza il visto sarebbe stato del tutto inutile. Così andò al Consolato italiano a Belgrado per fare domanda ma lo rispedirono in Kosovo dicendogli che era il consolato di Prishtina l’istituzione ad essere in carico per le questioni riguardanti i residenti nella provincia, che fossero questi albanesi o serbi. Questo significava che avrebbe dovuto fare richiesta per i documenti kosovari. Non che la cosa gli desse fastidio, non era mai riuscito a provare, neanche sforzandosi, quel senso di umiliazione o di sconfitta che molti suoi coetanei sembravano soffrire dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte delle autorità kosovare. A lui non interessava: Kosovo, Serbia, quello che gli compiaceva; bastava solo che lo facessero uscire da quel maledetto Paese. Il punto problematico era che per un serbo recarsi a Prishtina era più facile a dirsi che a farsi, forse nemmeno questo, visto che nessun serbo diceva mai di ‘voler andare a Prishtina’. Prese coraggio e andò, non aveva alternativa. Non avrebbe mai potuto pensare che per passare qualche giorno di assoluto relax in Italia avrebbe dovuto stressarsi così tanto. In meno di due giorni aveva percorso più di mille chilometri, speso più di cinquemila dinari, visitato almeno sei edifici governativi tra ministeri e consolati, senza, alla fine, essere riuscito a concludere niente. Appena entrato nel palazzo del consolato italiano vide un ragazzo uscire la cui espressione gli rimase impressa. Sembrava sconvolto, come se il mondo gli fosse caduto addosso. Si chiamava Lulzim.
Aldilà del Mare, Questura di Modena, Italia. Qualche mese prima.
Eccomi. Sono ormai ore che aspetto; l’inefficienza della burocrazia italiana non perde mai l’occasione di smentirsi. C’è anche da dirsi che ho scelto il giorno sbagliato per recarmi in Questura. Una fila infinita di extracomunitari aspetta pazientemente la proroga del permesso di soggiorno. Io fumo per uccidere l’attesa, la noia e me stesso. 42, finalmente il mio turno. Ufficio Passaporti. Mi porgono un foglio da compilare. Prima di scrivere il nome aggiungo la sigla ‘Dott.’. Devo ammettere che è una sensazione alquanto soddisfacente. Dottore … mi ci devo ancora abituare ma non suona male. Eh sì, mi sono appena laureato, uno dei momenti più rapidi e indolori della mia vita. Poco ricordo a dir la verità ma che importanza ha, sono finalmente libero, non esiste più bella sensazione al mondo. Presto sarei partito: Kosovo, il sogno di una vita. Una volta ottenuto il passaporto niente mi avrebbe più fermato, né visti o file interminabili davanti a consolati, né innumerevoli scartoffie da compilare. Un semplice timbro sul passaporto.
Quanti Lulzim e Dusan ho incontrato lungo la mia strada. Le loro sono semplici storie, e devo ammettere di essermi preso un bel po’ di licenza narrativa nel riportarle, ma è certo che raccontano la verità: il disagio vissuto da una generazione intera che non ha la libertà di muoversi, di partire, di viaggiare e, anche, di sentire poi la mancanza di casa. È difficile immaginare cosa significhi tutto questo per noi, per chi è nato in un Europa senza confini, senza dogane né passaporti o visti, dove le frontiere non sono state abbattute ma bensì riposizionate su nuovi confini.
Solo i sogni gli restano e per quanto gli uomini possano essere divisi da muri, fiumi od odi, i sogni sono ciò che li accomuna. Tutti, indistintamente, desideriamo sapere cosa c’è aldilà delle montagne.
Il Kosovo, ad oggi, è l’unico Paese dell’area dei Balcani Occidentali a non godere di un regime di visti liberalizzato (free-visa regime) per quanto riguarda il transito ed il soggiorno nei Paesi dell’Area Schengen – inferiore a tre mesi. Il processo di liberalizzazione che ha coinvolto l’area – Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina e Macedonia, inaugurato con il summit di Tessalonica nel giugno del 2003 e conclusosi in due fasi a cavallo tra il 2009 e il 2010, ha visto il Kosovo totalmente escluso.
In seguito all’avvenuta dichiarazione di indipendenza del Paese (17 Febbraio 2008), il Consiglio Europeo ha enfatizzato la volontà di ‘assistere lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea’, auspicando la possibilità per il Paese di godere di un regime di visti meno restrittivo ‘solo una volta che tutte le condizioni vengano soddisfatte e senza pregiudizio alla posizione degli Stati membri sullo status’. La prospettiva è diventata realtà quando, il 19 Gennaio del 2012, il dialogo sulla liberalizzazione dei visti è stato finalmente lanciato. A giugno dello stesso anno la ‘roadmap’ stilata dalla Commissione è stata consegnata al governo di Prishtina, contenente novantacinque criteri da soddisfare: dalla lotta alla criminalità organizzata alla protezione delle minoranze. Ora, il 2013 si apre con poche certezze – ancora nessuna data stabilita per la liberalizzazione – e tante speranze ma ciò che è certo è la paura che le spaccature all’interno dell’Unione per quanto riguarda lo status del Kosovo – Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro non hanno riconosciuto l’indipendenza del Paese – possano rallentare un processo già lento. Le sfide non sono poche, soprattutto per un Paese dove tasso di criminalità e corruzione sono tra i più alti in Europa, ma ci auguriamo che possano essere superate in nome di tanti ragazzi che l’Europa l’hanno solo vista sui libri.
Elezioni in Serbia: riflessioni a cavallo dell’Ibar
Di Giovanni Bottari

Il risultato delle elezioni in Serbia era scontato ancora prima che si andasse a votare. Stessi canditati, stessi toni, stesse storie. E per la terza volta consecutiva Boris Tadic, l’europeista nonché Presidente uscente, e Timoslav Nikolic, il “progressista” nonché ultranazionalista di vecchia data con alle spalle una storia con l’SRS (Partito Radicale Serbo) finita male e che europeista ci è diventato con il tempo e per opportunità politica, si sfideranno nel testa a testa per la poltrona presidenziale. Poco è cambiato dall’ultima volta che si sono visti insieme, a parte che la disoccupazione è aumentata, c’è più crisi, più macchinismo politico, insomma le solite cose. Deve essere difficile scegliere quando si ha davanti “un europeista che parla da nazionalista ed un nazionalista che parla da europeista” tant’è che molti serbi hanno deciso di non farlo. Il malessere politico però, che di solito tende a manifestarsi su posizioni estremiste, questa volta non ha premiato neanche la Destra Radicale, forse unica vera sorpresa di queste elezioni. Anzi. L’SRS, guidato oggi dalla moglie di Seselj, sotto processo all’Aja per crimini di guerra, e un tempo primo partito della Serbia, non è neanche riuscito a raggiungere la percentuale di voti necessaria (5%) da permettergli l’entrata in Parlamento.
Aldilà di questo, le elezioni si sono svolte all’insegna dell’Europa. Per la prima volta dalla caduta del regime di Milosevic tutte le principali forze politiche del Paese hanno riconosciuto l’adesione ai Ventisette come un passo necessario da compiere. A marzo il Consiglio Europeo ha formalmente confermato la Serbia come uno dei paesi candidati membri, avvicinando di un altro passo il Paese all’Europa. Ma resta ancora un punto da risolvere: il Kosovo.
Se di Europa si è parlato tanto; di Kosovo si è solo accennato in maniera molto vaga. L’argomento scotta. Il problema dello status del Kosovo è strettamente legato all’adesione della Serbia all’Unione Europea ed un mancato compromesso a riguardo potrebbe ritardarne di molto l’entrata. Nessuno durante la campagna elettorale ha apertamente dichiarato di voler abbandonare la Regione ma d’altro canto nessuno è neanche stato in grado di dare risposte concrete alla questione.
Si richiede un passo avanti di Belgrado che se anche non lo vuole ammettere inizia a pensare che il Kosovo sia diventato una spina nel fianco. Se un tempo il grido “Kosovo è Serbia” si levava a gran voce dai palazzi del potere, oggi quel grido ha perso gran parte della sua carica evocativa e si è rivelato essere quello che è: un vero pantano politico.
Non sono molto le strade che Belgrado a davanti. Andarsene significherebbe riconoscere l’indipendenza del Kosovo ed abbandonare ad un destino incerto i 120.000 serbi che attualmente là risiedono, la maggior parte segregata a Nord del fiume Ibar o in piccole enclave sparse su tutto il territorio. Restare, d’altro canto, significherebbe un’eventuale revisione dei confini che minerebbe il debole equilibrio dell’intera regione Balcanica.
Nel mezzo c’è Mitrovica. Mitrovica è una tutt’altra che tranquilla cittadina situata a cavallo del fiume Ibar, nel Nord del Kosovo. Città diventata tristemente famosa per la sua divisione e che il suo ponte, di cui si è tanto parlato, ne è diventato il simbolo. Paradossalmente però il ponte è anche l’unica cosa che unisce le due parti della città e paradossalmente forse questo è anche l’unico luogo dove se un alternativa se esiste può essere trovata.
Attraversato il ponte verso Nord si entra nella parte serba della città, un qualcosa di politicamente non definito che non è ne Kosovo ne Serbia. L’autorità di Prishtina non arriva da questo lato del fiume e Belgrado è sempre più lontana. La ripetizione quotidiana dell’assurdo ha finito per dare una parvenza di normalità alla situazione e dopo alcuni minuti di confusione si inizia ad abituarsi. L’atmosfera è calma ma tesa. Le barricate sono diventate ormai parte dello scenario urbano e nessuno sembra farci più tanta attenzione. Le strade sono ancora invase dai manifesti elettorali. Anche qua si sono celebrate le elezioni come in tutta la Serbia ma con molta più sfiducia; in pochi sembrano veramente convinti che le cose possano cambiare, qualsiasi sia il politico che siederà a Belgrado. Negli ultimi anni la situazione non è andata migliorando di molto e la tanta incertezza non ha fatto altro che aumentare il senso di solitudine e di abbandono. Incontro Dijana e Tijana, due studentesse serbe, in un caffè. Parliamo di elezioni. “I politici sono tutti uguali” mi dice Dijana, “Tante parole ma poca sostanza. In tutti questi anni non fatto altro che promettere e alla fine non abbiamo visto niente. Abbiamo votato ma per cosa. Per un Parlamento o un Presidente lontani decine di chilometri da qui mentre la nostra voce viene continuamente ignorata. Siamo stranieri a casa nostra. La verità è ci stanno abbandonando tutti, uno dopo l’altro. Il Kosovo non esiste più, ora c’è solo l’Europa”.
“Nessuno sa cosa significhi vivere qui. Quanto sia difficile non poter attraversare un ponte senza la paura di andare dall’altra parte solo perché si è serbi o albanesi. Questo Belgrado e Prishtina non lo sanno. Prendono accordi senza consultare minimamente la popolazione. Io personalmente sono pessimista. Non ho più fiducia nella politica”. Dijana e Tijana sono iscritte al secondo anno dell’International Business School di Mitrovica ed ogni giorno quel ponte lo devono attraversare per andare a svolgere le ore di tirocinio richieste dalla loro università presso una ONG locale. “È l’unica possibilità che abbiamo. I nostri amici dicono che siamo pazze ad attraversare il ponte ma cosa dobbiamo fare. A volte abbiamo paura che qualcuna ci veda così cerchiamo sempre di passare dietro le barricate per farci notare il meno possibile.” I ragazzi con cui lavorano sono i primi albanesi che conoscono. “Sono dei bravi ragazzi. Personalmente noi non abbiamo nessun problema a lavorare con loro. Ma sai non tutti sono come noi. C’è ancora tanto odio qui”. Loro sono stanche di tutte questa divisione. Vorrebbero almeno una sera poter andare a bere qualcosa dall’altra parte della città, conoscere gente nuova, cambiare un po’, ma è ancora troppo pericoloso attraversare il ponte di notte. Le domando cosa pensano dei militari posti a pattuglia del ponte. “Beh sono tanti anni ormai che sono lì. Sono diventati parte della città in qualche modo” sorridono, “sicuramente ci sentiamo più sicure ad attraversare il ponte con loro. Ma ogni tanto penso anche che tutti quei soldi potrebbero essere spesi in modo diverso. Non c’è lavoro qui in città ed i giovani passano tutto il giorno dentro i Bar a non fare niente. E questo di certo non aiuta a migliorare le cose. Non c’è futuro qui. Per questo noi stiamo studiando. Vogliamo andarcene.” Comunque non hanno dubbi, sarà Tadic ha vincere le elezioni. Il prossimo 20 maggio si svolgerà il ballottaggio tra i due candidati presidenziali. Le forze internazionali presenti in città sono state aumentate per evitare ogni possibile tensione. Chiunque dovesse vincere le elezioni è ora che faccia i conti con questa realtà quotidiana. Staremo a vedere.
SIN TIERRA NO HAY VIDA...SIN CAMPESINOS NO HAY COMIDA
Città del Guatemala, 30 marzo 2012
di Giacomo Cantini

Il 19 marzo più di mille contadini guatemaltechi, provenienti da diverse comunità degli altopiani centrali del paese, hanno cominciato da Cobàn una marcia verso la capitale, per la difesa della Madre Terra, contro gli sgomberi forzati (desalojos) delle comunità rurali, contro la criminalizzazione dei movimenti sociali e per l'approvazione della Legge di Sviluppo Rurale Integrale, che conterrebbe la maggior parte delle altre rivendicazioni.
La Marcha Indigena, Campesina y Popular è senza precedenti in quanto è partita come una mobilitazione di base, fatta di persone, ed è riuscita nell'intento di unire movimenti e comunità di diverse zone del paese, accomunate dal fatto di subire da un lato le politiche del governo in tema di gestione della terra e repressione, dall'altro le occupazioni da parte di aziende transnazionali di territori comunitari, per lo sviluppo di centrali idroelettriche e miniere.
Durante il percorso di 214km ogni giorno hanno continuato ad aggiungersi manifestanti e all'entrata in capitale il 27 marzo, dopo nove giorni di camminata, la Marcia contava più di 2000 partecipanti. I messaggi di solidarietà sono stati ancora più numerosi e hanno contribuito a fare di questa iniziativa una questione nazionale, risvegliando il malcontento diffuso rispetto ai problemi sociali, economici, politici e culturali che non sono mai stati fronteggiati adeguatamente da nessun governo. Nella notte tra il 27 ed il 28 i rappresentanti della Marcia sono stati ricevuti dal Presidente dello Stato Otto Pérez Molina, che formalmente ha dichiarato di impegnarsi per la risoluzione delle problematiche presentate.
Nella conferenza stampa di stamattina, 30 di marzo, Daniel Pascual del Comité Unidad Campesina (CUC) ha però sottolineato che questo movimento non si fermerà fino a quando non siano attese concretamente tutte le rivendicazioni portate alla luce dell'attenzione pubblica, le quali afferma essere molto chiare e puntuali. La necessità di risolvere la problematica agraria ed il condono del debito agricolo, la demilitarizzazione delle aree rurali ad alta conflittività, la cessazione della criminalizzazione e repressione dei movimenti sociali, l'attenzione ai problemi delle comunità del Polochic( ) e la cancellazione delle licenze di esplorazione e sfruttamento minerarie; queste, secondo i portavoce della Marcia, sono le principali richieste che dovranno essere affrontate dal governo. La speranza è che il 19 aprile, nella prossima riunione con l'esecutivo, questo ultimo presenti delle soluzioni ed un piano concreto di attuazione delle stesse. Nel frattempo, dichiara Pascual, la mobilitazione continuerà attraverso tutti i canali possibili e mediante tutte le azioni che siano necessarie, perchè questo è solo un primo, grande passo verso la costruzione di un Guatemala più giusto e democratico.
Per seguire gli sviluppi della Marcia, https://www.facebook.com/pages/Marcha-ind%C3%ADgena-campesina-y-popular/207724279334698
Foto: Manifestanti durante la Marcia (fonte: Pagina facebook della Marcha Indigena, Campesina y Popular)
(1) Nel marzo 2011, dopo che avevano fatto ritorno alle loro terre che già gli erano state tolte, sono state sgomberate da forze di sicurezza private più di 800 famiglie in 14 comunità della Valle Polochic, nel nord-ovest del paese).
KOSSOVO: PAGINE DI GEOGRAFIA PERDUTA
Reportage di Giovanni Bottari

Nei Balcani le cartine geografiche a poco possono servire al viaggiatore nel tentativo di orientarsi in un territorio dove la morfologia stessa prima di essere fatta di montagne, di laghi o di fiumi è fatta di popoli. Esiste un intricato rapporto tra territorio e popolazione spesso invisibile, difficilmente descrivibile, in particolare là dove non esistono confini definiti se non, appunto, quelli tracciati dalle mappe geografiche. Confini che finiscono per confondere il viaggiatore e deviarlo dall’essenza di questa terra.
Da qui inizia il mio racconto che, come i tanti che lo hanno preceduto, ha voluto o almeno ha cercato di tracciare un percorso tra tanti possibili.
Prishtina, Kosovo
Lungo l’autostrada che porta dall’Albania in Kosovo, non sono solo le montagne a scorrere davanti agli occhi del viaggiatore. Innumerevoli sono i graffiti che costellano le pareti a lato della carreggiata. Guardandoli si può ripercorrere la storia di una nazione e la loro successione grafica sembra quasi riflettere il susseguirsi del tempo.
La storia non traccia un cammino cronologicamente lineare composto da eventi che si susseguono secondo un rapporto di cause - effetto ma sembra quasi ripetersi, saltare, muoversi intorno. Hegel diceva: “La storia si ripete sempre due volte ma la seconda è solo una farsa della prima”. I Balcani sono l’esempio pratico e lampante della massima hegeliana.
 L’arrivo a Prishtina è accompagnato dal ticchettare della pioggia sulla carrozzeria del vecchio autobus. La strada scivolosa sembra quasi proiettare il cammino verso l’indipendenza. Le ruote stridono a contatto con l’asfalto, quasi come se si dovesse sbandare da un momento all’altro. Basta un niente per finire fuori strada.
L’incubo del passato non ha lasciato queste terre e impedisce un sonno tranquillo. È notte quando scendo alla stazione; la città sembra dormire; le uniche luci accese nella notte buia sono quelle del grande palazzo del UNMIK (United Nation Interim Administretion Mission in Kosovo). Una costruzione moderna che poco ha a che vedere con il paesaggio circostante. I bar, affollati di gente, riflettono la situazione nel paese: mancanza di opportunità, bicchieri vuoti, puzza di alcool e sigarette e un’intera generazione senza futuro. Mi sembra di rivedere un’immagine già vista troppe volte. Ordino una birra e condivido insieme ad altri un sorso di amaro destino.
Il giornale lasciato sul tavolino scrive di nuovi scontri nel nord del Paese tra i soldati del KFOR (Kosovo Force) e civili di etnia serba.
La regione del Kosovo nella storiografia serba rappresenta la <<Vecchia Serbia>>: il cuore di un Regno che durante il suo massimo splendore univa le rive dell’Adriatico con quelle del Mar Nero; questo molto prima dell’invasione ottomana, della nascita di Tito e della stessa Jugoslavia.
Fu qui, poco fuori la capitale kosovara, che il 28 giugno del 1389 l’esercito serbo, sotto la guida del Principe Lazar, veniva annientato dalla armate ottomane decretando la fine di un Impero e l’inizio del dominio. La leggenda vuole che il Principe Lazar abbia sacrificato se stesso (fu decapitato quello stesso giorno) e il suo Regno ‘terreno’ in vista di un nuovo Regno ‘nei cieli’; il suo sacrificio permise all’Europa cristiana di resistere all’avanzata ottomana. Molte famiglie serbe vennero scacciate dalle proprie case per non farci mai più ritorno.
L’immolazione non fu mai dimenticata e quella data venne marchiata a fuoco sulla pelle. Quel 28 giugno a Sarajevo durante il quale venne ucciso l’Arciduca Francesco Ferdinando decretando l’inizio della Prima Guerra Mondiale, lo stesso che Milosevic scelse 75 anni dopo per pronunciare il suo famoso discorso.
L’intera memoria storica di un popolo è racchiusa tra queste montagne, all’interno dei suoi simboli di massa e dei suoi monasteri (il monastero di Pec è tutt’oggi uno dei più importanti luoghi di culto per l’ortodossia serba).
L’Europa stessa nelle cui mani è lasciato il futuro di un popolo, non trova unità sull’azione; divisa, arranca senza trovare soluzioni. Questo manifesta tutta l’incertezza sul futuro. Il fallimento in Kosovo potrebbe determinare una frattura inguaribile per l’intero progetto.
Nel vuoto lasciato dall’incertezza, la criminalità cresce e come un cancro si espande ed estende la propria mano sulla società. Le strade, un tempo vuote, si riempiono di automobili di grossa cilindrata, europee, dai finestrini oscurati; si allontanano nella notte mentre mi avviò verso casa.
 All’esterno del Palazzo della UNMIK vi è un piccolo cimitero. Non ci sono ne tombe ne croci ma solo le fotografie dei tanti che non hanno fatto più ritorno a casa. Giovani, anziani, bambini. Quei volti sbiaditi dalla pioggia appesi lungo le cancellate che circondano l’edificio riportano la memoria indietro nel tempo agli anni bui della repressione e della guerra. La ragione perché si trovano qui e non in un altro luogo è semplice: per non dimenticare. Perché non si può e non si deve dimenticare; per ricordare ai governanti, ai diplomatici, ai funzionari delle Nazioni Unite, ai militari della NATO l’orrore di quanto accaduto. Una grande lastra riporta scritte in albanese ma riesco facilmente a immaginarne il significato. A differenza della nascita accanto ad ogni volto, la morte o la sparizione è arrivata per tutti nello stesso intervallo di tempo: 1995-1998. All’esterno del Palazzo della UNMIK vi è un piccolo cimitero. Non ci sono ne tombe ne croci ma solo le fotografie dei tanti che non hanno fatto più ritorno a casa. Giovani, anziani, bambini. Quei volti sbiaditi dalla pioggia appesi lungo le cancellate che circondano l’edificio riportano la memoria indietro nel tempo agli anni bui della repressione e della guerra. La ragione perché si trovano qui e non in un altro luogo è semplice: per non dimenticare. Perché non si può e non si deve dimenticare; per ricordare ai governanti, ai diplomatici, ai funzionari delle Nazioni Unite, ai militari della NATO l’orrore di quanto accaduto. Una grande lastra riporta scritte in albanese ma riesco facilmente a immaginarne il significato. A differenza della nascita accanto ad ogni volto, la morte o la sparizione è arrivata per tutti nello stesso intervallo di tempo: 1995-1998. In piedi dinanzi a quei volti è difficile restare lucidi e non farsi prendere dall’emozione. Immensa è stata la sofferenza di questo popolo: prima la segregazione, poi gli spostamenti forzati e infine la guerra. Questo solo per essere figlio di madre e padre albanesi e abitare in una terra dove i nonni dei tuoi nonni hanno per secoli abitato.
Si vorrebbe dimenticare ma non si può e non si deve. Ricordare è importante perché solo attraverso la coscienza del passato si può costruire un futuro senza tragedie. Quelle fotografie non cercano vendetta ma vogliono solo la pace. Questo, forse, è il vero significato di quel piccolo altare. Per secoli non è stato insegnato altro che odio; intere generazioni non hanno conosciuto altro che guerra. L’amore e la pace sono estranee. Invece che di scuole e ospedali, il Paese è lastricato di tombe. Il passato non può essere ne cancellato ne cambiato ma può essere ricordato per costruire il futuro. La comprensione e il dialogo sono l’unica via. Ma troppe sono ancora le grida di vendetta che superano di molto quelle di comprensione. Il passato, non troppo lontano, è ancora troppo vicino per essere superato. Allontanandomi lascio alle mie spalle le parole “FUCK SERBIA” disegnate sul terreno davanti alla statua del condottiero albanese Giorgio Castriota Skandrebej. Due bambini giocano all’ombra della sua figura. Temo per il loro futuro. Le mie lacrime si aggiungono al mare versato da chi per l’odio ha perso tutto.
Uskub (Skopje), F.Y.R.O.M (Macedonia)
Lo sguardo fiero di Alessandro Magno volge lontano. Nessuno sa esattamente dove, forse verso qualche confine lontano come a lui spesso piaceva sognare o forse, come piace sognare a qualcuno, verso Atene. Interamente coperta di Bronzo, la statua domina la piazza. È incredibilmente maestosa; due volte grande la sua gemella greca. Vengo a conoscenza del costo della statua: venti milioni di euro spesi per costruirla. Sotto la sua ombra turisti passeggiano ammirandone i particolari e bambini gitani a piedi scalzi gironzolano in cerca di qualche dinaro.
Dall’altro lato della piazza, sulla riva del fiume Vardar, l’Imperatore bizantino Giustiniano siede su un grande trono di marmo bianco. In ogni angolo è possibile intravedere statue e epigrafi che rammentano stralci di storia passata. Il ritratto perfetto di un epoca di splendore e gloria interrotta di tanto in tanto da immagini che nulla hanno da invidiare a un qualsiasi paesaggio di degrado cittadino. Da centro del Mondo a periferia di un grande Impero in pochi passi. La Skopje del nuovo millennio si innalza dalle rovine di un passato ottomano: moschee, fortezze e bazar fanno da sfondo alle nuove costruzioni.
Più di ogni altra cosa ciò colpisce è il mosaico di popoli ed etnie; un’eredità lasciata ai posteri dalla caduta dell’Impero Ottomano. La Macedonia rappresentava il punto di incontro: il luogo dove tutte le tensioni e gli odi etnici e religiosi che attraversavano la Porta trovavano la loro intersezione. Una ricostruzione in miniatura dove odio e fame di grandezza facevano da sfondo e la Storia di tanto in tanto dava qualche anticipazione circa il futuro.
La Macedonia faceva parte del vilayets albanese del Kosovo ma allo stesso tempo era parte dell’antico Regno bulgaro (la stessa lingua macedone non era altro che bulgaro e in fin dei conti lo stesso macedone non era altro che un bulgaro), dell’antico Impero bizantino e dell’antico Regno serbo. A questa situazione di tensione e frammentazione etnica si aggiungeva l’inefficienza di Costantinopoli. A cavallo tra il XIX e il XX secolo la Macedonia era una bomba a orologeria, in preda ad una spirale di violenza senza fine dove l’atrocità delle truppe turche era superata solamente dal terrorismo dei gruppi separatisti.
Le ferite non si rimarginano facilmente e il tempo difficilmente riesce a cancellare un odio che tempo non ne ha. Le popolazioni balcaniche hanno nostalgia del loro passato glorioso e le loro dispute moderne si tingono di un nazionalismo ancestrale che non segue il passare del tempo ma rimane bloccato nel punto in cui l’orologio della storia segnava l’ora del massimo splendore. Le rivendicazioni di conseguenza seguono la medesima logica: reclamano, come loro territori naturali, tutte quelle terre che a loro appartenevano al tempo della massima espansione.
La Macedonia diventa la vittima predestinata. Il suo essere tale come il suo stesso nome rimbomba per l’intera penisola quasi fosse un eco di guerra. Il dare alle cose il loro vero nome nei Balcani non è una atto rivoluzionario ma un’offesa.
La regione geografica della Macedonia supera di gran lunga i confini dell’omonimo Stato inglobando parti della Grecia settentrionale (Salonicco fa parte di questa, o meglio Tessalonica per i greci), della Tracia (la Turchia europea) e della Bulgaria occidentale. L’accusa sarebbe che la Macedonia, solo perché è stata così chiamata, in un futuro non troppo lontano possa avanzare pretese sulle cartine geografiche.
Eppure il ragazzo macedone innumerevoli volte ha oltrepassato le frontiere, ha amici grechi, bulgari e serbi. “Per quale motivo dovrei odiarli?” mi dice “cosa mi hanno fatto. Il Nazionalismo è roba da vecchi fanatici e reazionari”. Come tale si crea e si perpetua nelle menti di chi per paura di guardare al futuro rimane legato ad un passato lontano.
Il nazionalismo non esiste in natura.

Per la strada, da qualche parte al confine tra Kosovo e Macedonia.
Il modo migliore per conoscere un paese è quello di fraternizzare con i suoi abitanti. L’autostop nei Balcani si è rivelato il miglior mezzo di trasporto, non tanto per la possibilità di viaggiare a costo zero, quanto per quella dell’incontro. Il paesaggio illude la mente. Non vi sono costruzioni che possano definire con certezza il luogo in cui si è: potrebbe essere allo stesso tempo una lontana provincia del Medio Oriente come una campagna sperduta nel cuore degli Stati Uniti. Un luogo selvaggio, incontaminato, dove l’occidente con la sua globalizzazione stenta ad arrivare se non fosse per le pompe di benzina dai nomi indiscutibilmente europei che di tanto in tanti si incontrano lungo il cammino. La facilità di ottenere un passaggio è incredibile. Le macchine, gli autocarri, i camioncini si fermano uno dopo l’altro. Mi domando quanto tempo avrei dovuto aspettare a casa mia per ottenere, e se mai l’avessi ottenuto, un qualcosa di lontanamente simile.
La malattia dell’individualismo che la globalizzazione si porta dietro e distruggere il sentimento di appartenenza ad un qualcosa di più grande dell’io, qui sembra non esistere. Tutti sono ben felici di accogliermi sui loro mezzi, di ascoltare la mia storia e io di ascoltare la loro, di aiutarmi se possono in qualsiasi modo. Sono convinto che si abbia molto da imparare da questa terra, qualcosa che noi abbiamo dimenticato e che supera in bellezza qualsiasi conquista del mondo civilizzato.
Faccio svariate decine di chilometri nel retro di un piccolo camioncino che porta un intera famiglia a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne. Il vento e la freschezza della sera allevia il calore di una giornata d’estate. Provo una strana felicità che mai avevo provato prima d’ora.
Vengo lasciato all’inizio di un bivio, i nostri destini si salutano e anche se non rivedrò mai più quei volti sono felice di aver condiviso con loro una parte, anche se insignificante, della mia vita. “Ne Prishtine” rispondo a chi si ferma e mi domanda. Passano un paio di minuti prima di trovare qualcuno che vada nella mia stessa direzione. Il mio compagno di viaggio si rivela essere un uomo sulla cinquantina, molto simpatico e socievole. Parla un inglese perfetto e questa volta sono io a trovarmi in difficoltà durante la conversazione. Scopro che prima della guerra lavorava nell’aeroporto della capitale come dirigente del traffico aereo. La guerra lo ha costretto a lasciare tutto quello che possedeva e a scappare con la sua famiglia. Mi racconta della interminabili file di esseri umani che abbandonavano la città, decine di migliaia, con pochi oggetti personali mentre alla spalle si lasciavano il fumo nero ed il rumore delle bombe. Adesso è il direttore delle Acciaierie di Ferizaj, le più importanti del paese. Parliamo del futuro, mi dice che il suo paese ha voglia di crescere, ha voglia di futuro, ma questo gli è negato da una classe politica immobile troppo collusa con la malavita. Sogna di ritornare a lavorare nell’aviazione civile ma il domani è incerto. Mi accompagna fino alla porta alla porta della residenza universitaria. Mi lascia il suo numero di telefono e mi supplica di chiamarlo per qualsiasi problema; dice che avrebbe piacere a rivedermi e parlare ancora con me. Non rivedrò più quell’uomo.
Mitrovica, Kosovo Settentrionale
Seduto ai tavolini di un bar osservo il fiume Ibar attraversare la città nel suo corso lento e tranquillo. Le montagne che si stagliano in lontananza non sembrano dare alcun sollievo al caldo estenuante. Più in là, all’ombra del ponte, bambini gitani cercano ristoro nelle acque del fiume. Sopra le loro teste, divisioni delle forze NATO pattugliano annoiate il passaggio sul ponte. Gli unici mezzi a passare sembrano essere veicoli militari, di tanto in tanto un’autovettura che noto essere tutte senza targa.
Il famoso ponte di Mitrovica: una struttura a metà strada tra l’architettura futurista e l’edilizia medievale. Il triste simbolo della divisione non solo di una città ma di un paese. Una divisione non ideologica, astratta, ma visibile, tangibile quasi come avesse un odore e una forma. L’atmosfera calma e tranquilla assomiglia a quella che precede una tempesta. E quando questa arriva il ponte viene chiuso delle autorità; perfino una partita di pallacanestro si può trasformare in un pretesto per lo scontro e terminare nel sangue. Le scritte sui pilastri che reggono il ponte vomitano odio.
Chiedo ad un soldato italiano di pattuglia se sia sicuro compiere una piccola visita aldilà del ponte. Mi rassicura, oggi la situazione sembra essere tranquilla. Quello stesso giorno, a poche decine di chilometri da Mitrovica, al confine tra Kosovo e Serbia, le autorità kosovare avevano perso il controllo di alcuni posti di frontiera.
Attraversiamo il ponte … la sensazione è simile a quella che si prova nell’oltrepassare un confine tra due Stati, solo amplificata di molte volte. Un confine non segnato sulle mappe geografiche ma certamente visibile. Due enormi bandiere serbe aprono l’entrata: non è difficile capire da che lato della città si sta camminando. Le insegne dei caffè, le targhe, le stesse persone cambiano. L’unica cosa a restare uguale è il significato delle frasi disegnate sui muri, ora scritte in cirillico: l’odio è lo stesso. Ovunque appaiono croci serbe a ricordare.
È incredibile come una città possa cambiare tanto il proprio volto in un centinaio di metri. Eppure quante le città che hanno condiviso o condividono un simile destino: quante le Berlino, le Mostar, le Nicosia, le Gerusalemme.
Nella terra della divisione anche una macchina fotografica può essere di troppo. Il turista che immortala i momenti del suo viaggio con un flash può facilmente essere scambiato per un giornalista in cerca della notizia. Io potrei essere l’uno e l’altro o nessuno dei due, eppure non sono ben accetto. Mi ritrovo in una piazzetta a scattare qualche fotografia a dei bambini che giocano con un pallone, l’atmosfera è l’ideale per portare a casa un bel ricordo. D’un tratto sento dei fischi che provengono dal patio esterno di un bar; mi viene fatto cenno di avvicinarmi. “Show me your passport!” pronunciato in un imperativo che non ammette repliche. Nessun distintivo o divisa che possa conferire a quell’uomo una qualche autorità. Rifiuto di consegnare le mie generalità. Sbaglio. La situazione inizia a surriscaldarsi e richiama l’attenzione di altre persone; l’insistenza si tinge di rabbia. Io e il ragazzo austriaco al mio fianco cerchiamo di restare calmi. Lui mastica un po’ di serbo e prova a calmare la folla ormai radunata intorno a noi. Nel suo delirio politico veniamo qualificati come possibili terroristi albanesi. Una volta scoperta la sua origine, offendono il mio compagno con parole inneggianti al nazismo, lui risponde a tono con una fermezza che non potrò mai dimenticare. “You don’t call me Nazi as I don’t call you Chetnik” (i Cetnici o Esercito Jugoslavo in Patria fu un movimento di matrice nazionalista, conservatore, anti comunista e monarchico che durante la Seconda Guerra Mondiale si oppose all’occupazione nazista e al regime ultranazionalista degli Ustasha e nello stesso momento ai partigiani di Tito. I movimenti paramilitari cetnici si sono macchiati di orribili atrocità durante le Guerre Balcaniche).
Gli occhi dell’uomo brillano di una strana luce, può essere scorta rabbia, sconcerto, tristezza. Abita in questa città da 47 anni; questa è la sua città, la sua terra. Gli albanesi già posseggono una terra che si chiama Albania. Incolpa i nostri Stati di aiutare i terroristi albanesi e l’Unione Europea di supportare criminali come Hashim Thaci: “Give me only one reason!” urla. Non riesco a dire una parola, immobilizzato dalla paura continuo il volto di quell’uomo, la sua rabbia, il suo dolore.
Eppure, penso, questa continuerà ad essere la sua casa e forse anche quella dei suoi figli nonostante possa chiamarsi con un nome differente o possa essere governata da persone differenti. I suoi diritti rimarranno tali e verrà trattato come un qualsiasi altro cittadino. Se così non dovesse essere la Storia è destinata a ripetersi; non giustificherò il suo odio o le sue azioni, ma forse potrò capirle.
Arriverà il giorno che il vicino verrà chiamato compagno e non visto come un nemico. Ma i tempi non sono ancora maturi, fresco è ancora l’odore del sangue e dell’odio che imbratta i muri. Probabilmente nello stesso punto dall’altra parte della città c’è un uomo come lui che pensa le stesse cose. Non so chi abbia ragione ma so che è stupido continuare testardamente ad affermare la propria di ragione, seduto a un tavolino, senza provare ad ascoltare o dialogare. La verità sta nel mezzo come quel piccolo ponte che divide ma nello stesso momento unisce. Basta solo vedere le cose dal lato giusto.
 Giudicare senza conoscere è la prima cosa che di solito viene da fare, la più facile e certamente la più sbagliata. Le persone sono quello che vogliono essere aldilà di un appartenenza religiosa, politica o etnica. Il pregiudizio per troppo tempo ha insanguinato queste terre più della stessa guerra e dello stesso odio. Si sono commessi tanti errori nell’arrivare a questo punto della Storia; errori che non sono ancora stati pagati e mi auguro lo siano in un futuro non troppo lontano. Ricominciare è possibile, continuare sulla via della vendetta, sulla strada dell’odio non porta in nessuno luogo. Vivere nel passato non allevia il dolore del presente ne rida ciò che è stato tolto. Forse non esiste soluzione a tutto questo ma solo attraverso il dialogo è possibile scoprirlo.
Le storie che ho ascoltato, ho vissuto, ho visto non mi hanno detto dove trovare il torto o la ragione o dove sia la colpa. Possiamo farci un’idea, sì, ma questa non sarà mai la verità, perché in fondo forse una verità non esiste affatto.
DANIMARCA: AVANTI I GIOVANI PROGRESSISTI
Di Matteo Tomasina
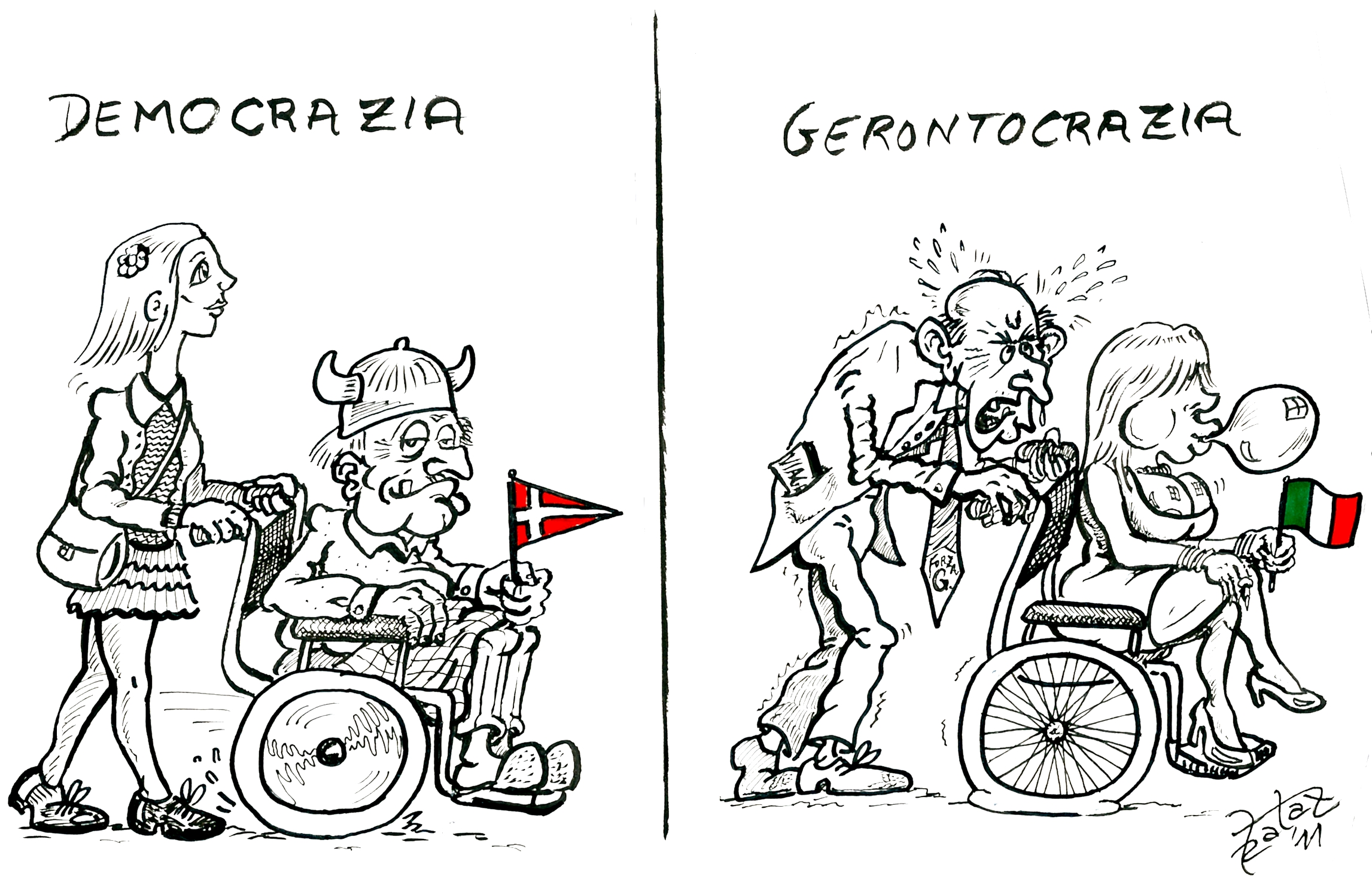
disegno di Francesco Tassi
C'è del nuovo in Danimarca: un governo in cui l'età media dei ministri è 43 anni e il più giovane, di 26 anni, è titolare del Fisco. Ciò che sarebbe fantapolitica in altri paesi, è invece realtà in Danimarca. La candidata premier del Partito Socialdemocratico Helle Thorning-Schmidt ha varato il 3 ottobre scorso il suo esecutivo. E' la prima donna alla guida politica del paese, e la sua squadra è la più giovane d'Europa.
Ha meno di trent'anni il ministro della Salute Astrid Krag, e 33 il ministro dell'Ambiente Ida Auken, mentre il membro più anziano è un cinquantasettenne. A 45 anni, la Thorning-Schmidt stessa è il primo ministro più giovane del continente (a pari merito però con l'inglese David Cameron). Nel suo esecutivo inoltre nove ministri su ventitrè sono donne, e Manu Sareen è il primo caso di ministro danese ad avere acquisito la cittadinanza dopo essere stato un migrante.
Si interrompono così dieci anni di egemonia del blocco liberale in Danimarca, e il lungo periodo passato all'opposizione dimostra di aver fatto bene alle capacità di rinnovamento del principale partito di sinistra del paese. Le preoccupazioni riguardo al futuro dell'efficientissimo e onnicomprensivo welfare state nazionale hanno probabilmente pesato molto sulla scelta degli elettori: i tentativi dei precedenti governi di destra di ridurre la spesa pubblica avevano infatti già sollevato proteste, in particolare nelle università. La vittoria dei progressisti pone il paese in controtendenza rispetto al resto d'Europa, dove prevalgono governi conservatori.
Il programma ambizioso con cui la Thorning-Schmidt ha vinto le elezioni prevede un investimento di 1,3 miliardi di euro di stimolo all'economia e la contemporanea promessa di ridurre del 40% (rispetto agli anni '90) le emissioni di anidride carbonica entro il 2020. Un obiettivo ancora più alto di quello posto in campo ambientale dalla destra, mentre rimane l'impegno del paese di convertirsi completamente al rinnovabile entro metà secolo. In modo simbolico, sei ministri hanno deciso di recarsi alla loro nomina in bicicletta, per rimarcare il carattere “verde” dell’esecutivo.
Dal punto di vista dello stato sociale, nonostante quanto detto in precedenza, la situazione appare complessa. Il sistema danese è il più avanzato ed efficiente d’Europa, ma sono lontani i tempi in cui a Copenaghen si raggiungeva la piena occupazione e le disuguaglianza fra i redditi erano minime, tanto da far parlare di effettiva uguaglianza economica. Le diverse crisi e l'inizio delle migrazioni hanno modificato la situazione. Oggi la crescita della Danimarca è la più bassa fra quella dei paesi scandinavi, e anche i socialisti, in previsione dell'aumento del deficit, ritengono necessari dei tagli alla spesa pubblica. Sulle decisioni pesano gli equilibri all'interno della coalizione vincitrice: il PS governa con un'altra piccola forza di sinistra, e un partito radicale più moderato. Quest'ultimo ha posto il veto sia alla tassa sui milionari che a una tassazione ulteriore delle banche. Si prevede così l’aumento dell'età pensionabile e una riduzione dell'indennità di disoccupazione. Ma gli investimenti pubblici saranno indirizzati a creare più posti di lavoro per i giovani. Più “progressiste” le proposte di abbassare il costo dei trasporti pubblici (Copenaghen è già la capitale meno trafficata d'Europa), offrire incentivi per le automobili ecologiche, e semplificare il percorso per l’ottenimento della cittadinanza danese. Inoltre, visto l’amore per il salutismo, saranno previste anche tasse su sigarette e junk food.
C’è chi critica la continuità su molti punti con i conservatori, ma la novità politica danese non può non trasmettere l’impressione di un paese che vuole raccogliere le sue forze migliori per rispondere alla propria crisi, rimarcando l’uguaglianza di genere e di opportunità dei suoi cittadini. Inoltre il ricambio di classe dirigente è uno dei sintomi di buon funzionamento della democrazia, il sistema che dovrebbe permettere di sostituire i governanti in modo regolamentato e pacifico.
Un “caso danese” che ci costringe a una breve riflessione sull’Italia che, non a caso, si colloca all’estremo opposto, basti pensare che Silvio Berlusconi, con i suoi 75 anni, è il leader più anziano d’Europa. Per non parlare dell’età media dei suoi ministri (57 anni), e dei suoi giovani che occupano dicasteri considerati di minor rilievo (Ambiente, Pari Opportunità, Gioventù). Ad abbassare l’età media sono soprattutto le donne come Giorgia Meloni, 34 anni, che è la più giovane dell’esecutivo, anche se la sua presenza ai vertici appare più che altro una sorta di testimonianza. Nel governo danese quasi la metà dei ministri sono donna, in Italia la stessa percentuale si riferisce agli ultra-sessantenni. Un caso italiano di estrema lentezza nel ricambio della classe politica e di gerontocrazia che diverge molto da quello di paesi più affini. Un unicum in tutta Europa.
23/10/11
LA RIVOLUZIONE DEL MAGGIO SPAGNOLO
di Alessandro Verona

Il 15 Maggio è una data che la Spagna non dimenticherà, e che l'Europa deve riuscire a interpretare come sintomo del malessere verso una democrazia illusoria, come slancio alla ricerca della guarigione dalla malattia della politica asservita, dove con la partitocrazia odierna anche il voto perde valore.
Il 15 Maggio non è solo un giorno, è un periodo, una rivoluzione dei movimenti di massa, nei tempi, nelle forme, nell'espressione.
Un giorno che dura ormai da 6 giorni, un giorno che ha la forza di segnare un epoca, non a caso si parla sempre più di “spanishrevolucion”.
Le richieste del movimento sono semplici, ma pretese nella loro radicale purezza:
democrazia reale, controllo dei grandi agenti economici, una politica fiscale dedicata al reparto della ricchezza, una politica economica per il benessere di “davvero tutti”, pensioni degne, la tutela dei diritti dei lavoratori, del diritto al tetto, all'aria, a un ambiente salutare e all'acqua (quindi rigorosamente pubblica), del diritto all'educazione e alla salute, alla conoscenza e alla cultura, alla mobilità e alla cittadinanza universale.
Diritto, semplicemente ma non banalmente, a una buona vita.
Con le elezioni amministrative alle porte, in questo 15 Maggio nato sotto la forza di facebook in primis - esattamente come per le rivoluzioni arabe -, Madrid ha mostrato i volti, giovani e meno giovani, di chi non è più disposto ad accettare una scelta elettorale di stampo maggioritario fra partiti, PP, PSOE e CUI, sui quali regna la totale sfiducia, partiti che ragionano sulle assi del potere e della finanza allontanandosi sempre più dalle necessità reali delle persone.
Quelle persone che attraverso i media, quotidianamente, vedono i loro problemi sminuiti e messi in secondo piano, se non taciuti, rispetto a realtà a loro, a noi, estremamente distanti.
Migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi, donne e uomini di tutte le età, che hanno letteralmente riempito plaza del Sol, la piazza più centrale della capitale spagnola, in nome dell'articolo 21 della costituzione spagnola, che riconosce il diritto alla riunione pacifica senza armi senza che serva una previa autorizzazione.
Così, la notte dopo il 15 maggio di Madrid che ha dato voce alla frustrazione del popolo all'urlo di "Democracia real ya", Democrazia reale ora, un gruppo di 100 manifestanti ha deciso di accamparsi pacificamente in quella piazza fino alle elezioni, perché quella non fosse una sola manifestazione in più, perché il messaggio fosse davvero intenso, intenso come l'esigenza che lo spinge.
Quelle 100 persone sono aumentate rapidamente da subito.
E' così fiorito l'accampamento, e Sol, simbolo spagnolo e ombelico del suo turismo, si copre di teloni, si paralizza per la quantità di persone che scelgono di partecipare con la loro voce, i loro cartelli, le loro proposte, alla faccia di chi sostiene che la generazione di oggi non ha un forte sistema valoriale o non ha più a cuore la società.
Migliaia di mani cambiano il volto a quella que diventa plaza de la Solucion.
Si crea una moltitudine di comitati, centrale, legale, internazionale, del rispetto, della pulizia, che arrivano ad un'organizzazione perfettamente coordinata, mentre grazie alla solidarietà della gente si regalano ai partecipanti panini e acqua.
Su una lavagna il comitato centrale scrive di cosa c'è urgentemente bisogno, e, dopo averlo pubblicato attraverso facebook, arrivano altre tende, sacchi a pelo, cavi e lampade, teli cerati e cibo; persone di tutte le età offrono ciò che possono, dalle coperte alla manodopera, in un alveare di idee che non dorme mai.
La simpatia di gran parte della città è tutta concentrata qui, come se fosse la bocca delle sue sensazioni più viscerali di Madrid, come del Paese, e lo testimonia il fiorire di manifestazioni similari il tutta la Spagna. Ma anche in Europa.
L'aria che si respira è surreale.
Una piazza piena di persone che a tutte le ore del giorno e della notte discutono solo di politica, diritti e società, mentre si svolgono assemblee in ogni angolo, il comitato legale tiene costantemente informati i partecipanti, senza nemmeno l'ombra di una bandiera di partito, nazione o sindacato, nessun ubriaco.
E la percezione dell'entusiasmo di sentirsi parte di un cambiamento così penetrante da, sul serio, i brividi ad averlo davanti agli occhi.
In questo brulicare di idee, il 20 Maggio la piazza di Sol ha creato il suo manifesto, che si fissa punti tanto precisi quanto sacrosanti: il cambio della legge elettorale con circoscrizione unica e liste aperte, la tutela della casa e riforma della legge ipotecaria, la garanzia di una sanità pubblica e gratuita, di un'educazione pubblica, l'abolizione del piano universitario di Bologna (la riforma che ha portato alla laurea "3 più 2") e della locale legge Sinde sull'immigrazione.
E ancora una riforma fiscale che favorisca i redditi più bassi, una riforma lavorativa con tutela reale dei lavoratori e abolizione della pensione vitalizia, l'obbligo di presentare liste senza imputati o condannati per corruzione, nuove regole per istituzioni bancari e mercato finanziario.
In più lo svincolamento reale fra Stato e Chiesa, l'accesso popolare ai mezzi di comunicazione per un avvicinamento alla democrazia diretta, la regolarizzazione dell'economia sommersa, il rifiuto del nucleare e il recupero delle imprese pubbliche privatizzate, l'effettiva separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giuridico.
Infine la riduzione della spesa militare, la chiusura delle fabbriche d'armi, il controllo attento nei confronti delle forze dell'ordine e la trasparenza dei bilanci dei partiti.
Una nuova agorà ateniese, una fucina della società che sogniamo, dove i valori di una società collettivista e solidale si fanno forza a vicenda, dove non c'è spazio per la violenza e la voce è l'unica arma.
E sotto la luna in plaza del Sol, con quei brividi d'entusiasmo, si costruiscono le basi per far fiorire questo movimento in Italia, come in Europa.
Proprio oggi, 21 Maggio, scende "a la calle" il movimento italiano di "Democrazia reale ora", in piazza di Spagna a Roma e in piazza del Duomo a Milano, perché anche la nostra Italia, finora così bistrattata da una politica dei veleni, delle compravendite e dell'ingiustizia del potere, possa rialzare lo sguardo e il mento.
Questo è un movimento che mette con le spalle al muro la vecchia politica baronale, che si riempie la pancia disseminando sfiducia e distanza dalle istituzioni, un movimento che può far nascere davvero una coscienza sociale nuova.
E di realizzare questa speranza abbiamo tutti un enorme bisogno.
26/5/11 Madrid.
Giappone: la calma dopo la tempesta
di Giovanni Bottari
Osaka, Giappone
Ore 5.16 del 13 Marzo 2011
1gg, 14h, 30m dopo

La terra trema. Mai così forte prima d’ora. I grandi palazzi del paese dei manga oscillano come fossero ramoscelli mossi dal vento. Il mare si riprende la terra che un tempo fu sua, spazzando via interi villaggi costieri, un inferno di acqua e fango; quello che i giapponesi chiamano yabai (disastro).
Ma è quella calma disarmante a sconvolgere più di tutto, comune denominatrice dei volti di milioni di giapponesi, che quasi non trova spiegazione razionale di fronte alla tragedia.
A Occidente non si toglie lo sguardo dai telegiornali, immagini spaventose giungono dal Levante. Eppure.
Una massa uniforme di uomini e donne che si muovono secondo un determinato codice di condotta. La paura non sembra scorgersi sui loro volti.
Kazuo Miyato è uno di loro. Si fa chiamare così questo ragazzo italiano emigrato dalla Calabria fino alla terra del Sol Levante. “Sono ancora vivo” mi dice appena alzata la cornetta del telefono.
Sono i suoi occhi a parlare, ancora una volta con quella calma, dettata forse da una tradizione mistica e millenaria della terra degli antichi Samurai.
Dov’eri al momento della scossa?
“Ero a casa, stavo dormendo dopo una serata di lavoro quando sento oscillare tutto. Mi sveglio e chiedo alla mia ragazza che cosa sta succedendo. Mi risponde che forse è il terremoto, poi esce e va a lavorare.
Poco dopo, mi metto a studiare e arriva una nuova scossa, questa volta più forte.”
A questo punto ti sei allarmato?
“Qui ad Osaka la scossa è stata molto più breve e meno intensa; diciamo che dopo la seconda scossa c’è stata un po’ di preoccupazione, ma non esagerata. Se le scosse non hanno un magnitudo molto elevato qui non si allarma nessuno.”
Quindi, hai continuato la giornata tranquillamente?
Si … poi accendo la televisione e vedo un inferno su al Nord, la diretta dal luogo dello tsunami.
Sono andato a lavorare, ma solamente due ore; il locale era vuoto, erano tutti a casa a seguire in diretta gli sviluppi della tragedia.”
Era la prima volta che sentivi una scossa del genere?
Si, anche se tre o quattro se ne sentono ogni mese qui.
Hai assistito a scene di panico in strada?
Nessuna. Qui sono millenni che ci sono terremoti e tsunami. L’ultimo prima di questo fu a Kobe nel 1995, vicino a Osaka. Siamo preparati di fronte a questo. Anche se non si può prevedere con certezza la natura.
Cosa ti ha colpito di più di tutto questo?
La sicurezza di questo popolo, la perfezione che mettono in ogni cosa, anche nella più insignificante, la capacità collaborativa, l’organizzazione. Una grandezza d’animo come poche popolazioni al mondo.
Mi sento al sicuro qui, confido nelle autorità giapponesi. Non scappo, io resto qua.
Non posso abbandonare questa gente.
E se ci fosse una nuova scossa? Questa volta più vicina?
Resterei lo stesso, farei ciò che è in mio potere per aiutare i soccorsi. Mi ha donato tanto questa città con i suoi abitanti, non posso abbandonarla. Se così deve essere, il Giappone sarà la mia tomba.
Ti fa onore tutto questo. Che conseguenze credi avrà questo disastro sul Giappone?
In primo luogo sicuramente finanziarie, l’economia di questo paese ancora non uscito dalla crisi riceverà un nuovo pesantissimo colpo. La ripresa sarà molto più lontana.
Dopo l’incidente di Fukujima, che rischia di trasformarsi in un disastro nucleare, penso che si rifletterà a lungo sulla necessità del nucleare. Spero si opti per le energie rinnovabili, già largamente diffuse in tutto il paese.
Quali saranno le prossime mosse del governo giapponese?
Sicuramente in primo luogo si cercherà di tenere sotto controllo la situazione nucleare, evitando a tutti i costi grandi fuoriuscite di materiale radioattivo e evacuare le persone in prossimità delle centrali a rischio.
Risolvere il problema degli sfollati, che continuano ad aumentare nelle zone più colpite dallo tsunami, disponendo accampamenti provvisori, come già sta facendo il governo.
E fondamentale sarà rendere agibile il paese il prima possibile per accelerare l’arrivo dei soccorsi e evitare altre vittime.
C’è paura per l’emergenza nucleare? Ci sono già state delle fughe di materiale radioattivo?
Per il momento grandi fughe non ci sono state, però non si nasconde la preoccupazione per le prossime ore. La situazione potrebbe peggiorare. Comunque fonti governative hanno assicurato che non sarà un'altra Chernobyl.
Quindi si è già preparati al peggio?
Qui si dice che è stata una fortuna che il terremoto sia avvenuto in Giappone. In altri paesi, ora, i morti si conterebbero a milioni. Il Giappone è il paese tecnologicamente più avanzata per quanto riguarda le costruzioni antisismiche, quello che ha causato il vero disastro è stato lo tsunami. Come dicevo prima, la forza della natura è imprevedibile e devastante.
Sono previsti aiuti internazionali?
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha già fatto sapere che fornirà tutto l’aiuto disponibile. Per il momento sono state avanzate offerte da Russia e Corea del Sud. Penso che tutto il mondo sarà pronto a dare una mano di fronte a questo disastro.
Molto si ha da imparare da tutto ciò. Se i prossimi fossimo noi, sarebbe troppo tardi per qualsiasi lezione. L’Aquila ne è stato un esempio.
 
QUE PASA PRESIDENTE?
di Luca Biondi
In questi anni il continente sudamericano ha attraversato una fase di conversione politica. Questi paesi, tradizionalmente guidati da giunte militari autoritarie, hanno incominciato, solo da alcuni anni, a guardare a sinistra. Ma quest’”alba rossa” sembrerebbe già tramontare. C’è stato un momento, nei primi anni duemila, in cui tutti i paesi avevano governi socialdemocratici (a parte l’Ecuador) e alcuni come il Venezuela addirittura “socialisti”! Oggi le cose sembrano ritornare lentamente alla normalità. Ad esempio il tristemente famoso Cile, ultimamente, ha eletto un certo Piñera, ex apparatnì del generale Pinochet! Come dire: “Continuiamo così, facciamoci del male…” Perché tante speranze riposte in certi personaggi della rinascente America latina stanno ora vacillando? Sarà per le solite subdole manovre imperialiste della CIA o perché ci sono dei perfetti incompetenti a farsi promotori di queste nuove politiche? Guardiamo i fatti.

Il Venezuela. In questo paese l’ex parà e golpista Hugo Chavez ha finalmente promosso una lunga serie di politiche improntate al miglioramento della qualità della vita (nazionalizzazione dei giacimenti petroliferi, sistema sanitario gratuito, collaborazioni con Cuba, creazione di cooperative, ecc…) che però non stanno dando i risultati sperati. I sostenitori di Hugo sono entusiasti: dicono che ha portato la giustizia dove non c’era mai stata e che ha salvato il popolo dalla miseria. Essi lo idolatrano; Chavez conduce addirittura un programma televisivo che va in onda, a reti unificate, ogni domenica (Alò Presidente) la cui durata è a sua discrezione. La realtà purtroppo è ben lontana da quella che il capo assoluto vuol far credere. Egli ha sì varato una serie di “grandi opere” nella solita buona fede socialista, ma il paese è talmente complesso e arretrato che i benefici stentano a farsi sentire a chi ne avrebbe più bisogno. Oggi il Venezuela ha una nuova bandiera, una nuova “faccia”, ma nei barrios si vive ancora come una volta, se non peggio. Al 70% della popolazione non arriva l’acqua e ogni settimana, in media ci sono più di 50 vittime in agguati e omicidi nella sola Caracas! Sembra che esistano due poteri. Uno ufficiale, ma impotente (quello di Hugo) e uno reale, ovvero quello delle bande armate che di fatto controllano interi quartieri della città. Come si fa allora a dire “Vamos bien”? Per dirne un’altra a Pétare, sobborgo di Caracas, ci sono 400 bidonville e un litro di acqua potabile costa 25 volte più di un litro di benzina! Davanti a cose del genere non ci si sorprende più che Hugo abbia gravi difficoltà a mantenere alto il morale delle truppe (anche se l’esercito è ancora con lui). La riforma della Costituzione (un modo per permettergli di rimanere al potere, per portare avanti il lungo processo di conversione socio-economico), insieme all’oscuramento spregiudicato di alcune emittenti televisive, viene utilizzato dagli oppositori come pretesto per screditare l’immagine del governo e lavorare per permettere l’insediamento di un altro governo simile a quello filo-americano della Colombia, apparentemente “democratico”.
E’ meglio allora, avere la libertà ma rimanere nella miseria o è meglio non avere libertà ma con la speranza che i propri nipoti possano, un giorno, vivere in un paese migliore? Penso che questi cambiamenti debbano essere fatti, costi quel che costi. Anche a scapito della libertà di espressione: ci sarà un tempo per lottare anche per quella, ma non oggi. Oggi il Venezuela ha cose più importanti a cui pensare. Date tempo a Hugo, forse un giorno ce la farà, come un buon insegnante con una classe di studenti maleducati e ignoranti.
Alla luce della gravosa situazione in cui si trova oggi il Venezuela, con la sua stagnante rivoluzione, cosa stanno pensando i “vicini di casa”? Hanno forse intenzione di approfittare della situazione?
Si può ipotizzare, conoscendo come vanno certe cose, che agli Stati Uniti non sia piaciuta la mossa di nazionalizzare il petrolio venezuelano e che, prima o poi, abbiano intenzione di riappropriarsene. Ma non potendosi esporre, soprattutto da quando hanno un presidente premio Nobel per la pace, avrebbero commissionato il “lavoro sporco” al premier colombiano Uribe, generosamente ricompensato.
Uribe, secondo questa teoria, avrebbe il compito di appoggiare un “golpino”, attraverso la fornitura di armi e mezzi di comunicazione agli oppositori di Chavez, Costoro sono rappresentati per lo più da studenti universitari e famiglie del ceto medio di ex immigrati italiani (disarmati e lasciati da Chavez senza mezzi di propaganda come radio e tv). In questo modo il sogno socialista di molti si interromperebbe bruscamente, riportando il paese alla solita agonia da terzo mondo a cui siamo abituati, senza alcuna possibilità di riscatto. Il momento è buono: infatti l’esercito ha commesso un grave errore uccidendo, durante una manifestazione di protesta, due studenti. Questo potrebbe essere il frangente in cui alcuni agit-prop potrebbero, ben manovrati dall’estero, creare il caos all’interno del paese e mettendo in confusione le coscienze dei militari al servizio di Chavez. Alcune settimane fa due F-16 dell’aviazione americana hanno sconfinato sorvolando il delta del fiume Orinoco e il nord del paese; questo potrebbe essere il segnale di un possibile esperimento condotto per verificare le capacità di difesa della contraerea. Il Venezuela infatti ha recentemente acquistato 10 aerei da combattimento Shukoi, tutti made in Russia, come se prevedesse un possibile attacco aereo. Naturalmente questa possibilità (sinceramente remota) avverrebbe da sud, dove non ci sono agglomerati urbani, ma solo fitta vegetazione tropicale. Con il pretesto di eliminare definitivamente il movimento del FARC, gli aerei colombiani potrebbero farsi prendere la mano e… Questi non sono fatti ma solo ipotesi. Di sicuro però qualcuno, a Bogotà o a Washington, ha pensato di vendicarsi in qualche modo per l’audacia di Chavez. Del resto è noto che al confine Colombia-Venezuela sono da sempre in atto sospette manovre militari.
Probabilmente si tenderà infine a soprassedere sull’“arroganza” venezuelana nei confronti delle multinazionali e dei governi riformisti dell’America, perché il Venezuela ha saggiamente creato legami con amici forti e di tradizione bellicosa: Russia, Corea del Nord e Iran. Attaccare il Venezuela o permettere uno “sporco” cambio di governo, con esplicite motivazioni economiche, sarebbe come desiderare una terza guerra mondiale.Potrebbe esserci qualche protesta?
La guerra ai poveri dilaga
Keith Mann
In un recente discorso, André Bauer, governatore della Carolina del Sud, ha paragonato i poveri agli animali randagi. Citando sua nonna, ha dichiarato «che non bisogna nutrirli. Perché? Perché si riproducono». Anche per gli Stati Uniti, un Paese dove gli attacchi allo Stato assistenziale sono di lunga data, dove questa guerra ai poveri è quasi una banalità, le affermazioni del governatore si sono rivelate scioccanti.
Come spiegare tanta ostilità, aggressività? È vero che la Carolina del Sud non è esattamente un modello di progresso sociale. Fino al 2000, la bandiera sudista sventolava al fianco di quella degli Stati Uniti sul palazzo del parlamento dello Stato, un parlamento che conta una forte percentuale di discendenti afro. Solo dopo una massiccia campagna condotta dalle organizzazioni in difesa dei diritti civili è stata tolta. Come altri Stati del Sud, la Carolina del Sud ha leggi antisindacali che impediscono l’insediamento dei sindacati. Risultato? È uno degli Stati con uno dei più bassi tenore di vita.
Ma c’è un’altra ragione per questa guerra contro i poveri – che è contemporaneamente razzista e antioperaia. Oggi, quaranta dei cinquanta Stati sono alla bancarotta, le entrate fiscali si sono brutalmente ridotte in seguito alla disoccupazione (10% ufficialmente) e alla crisi strutturale e finanziaria. Aggiungiamoci le centinaia di miliardi di dollari sperperati in Iraq e in Afghanistan e si comprenderà perché le casse sono vuote. Ma, meno risorse significa più competizione per avere ciò che resta.
Campagna ideologica
Le affermazioni del governatore Bauer sono solo una manifestazione estremamente malvagia di idee molto diffuse. La classe dirigente ha bisogno di una campagna ideologica per fare accettare i disastri fatti dai tagli del budget. I poveri, dicono i conservatori e alcuni opnion makers, sono degli sfaticati, potrebbero lavorare, ma non lo vogliono, sono dei parassiti. Dare aiuto a questa gente sarebbe la peggior cosa perché annullerebbe la motivazione a lavorare, sostengono, malgrado simili argomenti siano smentiti da studi scientifici.
I veri parassiti
Nel 1994, 333 miliardi di dollari sono stati spesi per l’aiuto ai poveri…e 999 miliardi, tre volte di più, per l’aiuto sociale ai ricchi, essenzialmente delle deroghe fiscali. Più recentemente, attraverso il bailout, il piano di salvataggio, sono stati accordati oltre mille miliardi alle banche e alle assicurazioni, a Goldman-Sachs, a AIG, ai veri parassiti. Ci sarà un governatore per denunciarli?
Nuova task force USA per intervenire in America latina
di Antonio Mazzeo

Negli stessi giorni in cui è stata ufficializzata l’assegnazione del premio Nobel per la pace al presidente Barack Obama, l Dipartimento della difesa degli Stati Uniti ha annunciato la costituzione di una nuova e potentissima task force aeronavale destinata a presidiare i mari del continente latinoamericano. Si tratta del Carrier Strike Group CSG 1 e il suo comando operativo sarà attivato a San Diego (California). Come dichiarato dal Comando della III Flotta dell’US Navy che ne coordinerà gli interventi, “il CSG 1 sosterrà la strategia marittima nazionale, aiuterà nella promozione delle partnership regionali, farà da deterrente alle crisi, proietterà la potenza militare USA, promuoverà la sicurezza navale e fornirà assistenza in caso di disastri naturali all’interno di una vastissima area di operazioni dell’Oceano Pacifico”. La prima missione della forza aeronavale prenderà il via nella primavera del 2010 e si realizzerà “nelle acque del Sud America”. Imponente la potenza di fuoco del nuovo strumento di intervento militare statunitense.
Al Carrier Strike Group saranno assegnati una portaerei a propulsione nucleare, cinque fregate e due incrociatori lanciamissili, un centinaio tra cacciaintercettori, aerei a decollo verticale ed elicotteri, più alcune navi appoggio e di trasporto gasolio e munizioni. La nave ammiraglia sarà la USS Carl Vinson (CVN 70), portaerei della classe “Nimitz”, 103.000 tonnellate di stazza e una lunghezza di 332 metri, dotata di due reattori atomici della potenza di 194 Mw. Armata con sistemi missilistici Mk 57 “Sea Sparrow”, nel 2005 la Carl Vinson ha operato per sei mesi nel Golfo Persico appoggiando le operazioni di guerra in Iraq. Successivamente la portaerei è stata sottoposta a complessi lavori di manutenzione presso i cantieri navali di Newport (Virginia), di proprietà della Northrop Grumman, il gigante del complesso militare industriale USA che ha prodotto i velivoli senza pilota Global Hawk che stanno per giungere nella base siciliana di Sigonella. I lavori alla Carl Vinson, completati qualche mese, hanno permesso la “modernizzazione dei sistemi di combattimento e delle capacità operative dei velivoli trasportati” e il “rifornimento degli impianti di propulsione nucleare necessario a prolungarne il funzionamento per altri 25 anni”. Il gruppo aereo che sarà trasferito a bordo della porterei sarà il Carrier Air Wing Seventeen (CVW-17), con base a Oceana (Virginia), sino al giugno 2008 operativo dalla portaerei USS George Washington. Il CVW è composto da cinque squadroni dotati di caccia F/A-18E “Super Hornet” ed elicotteri per la guerra aeronavale ed elettronica, l’intercettazione e la distruzione di unità di superficie, sottomarini, aerei e sistemi missilistici nemici. Le capacità belliche del gruppo di volo sono state ripetutamente utilizzate dal Pentagono in occasione della prima e della seconda Guerra del Golfo e, più recentemente, nel novembre 2007, durante la sciagurata controffensiva alleata a Fallujah (Iraq), quando furono eseguite sino a quaranta missioni di bombardamento al giorno. Della nuova task force aeronavale faranno pure parte il Destroyer Squadron - DESRON 1, costituito da cinque fregate della classe “Oliver Hazard Perry” (tutte dotate di cannoni Oto Melara 76mm/62 e Phalanx CIWS, lanciatori per missili “SM-1MR” ed “Harpoon” ed elicotteri “SH-60 Seahawk Lamps III”) e dagli incrociatori USS Bunker Hill e Lake Champlian della classe “Ticonderoga”, equipaggiati con sistemi missilistici a lancio verticale “Mk. 41 VLS”, missili RGM-84 “Harpoon” e “BGM-109 Tomahawk”, quest’ultimi a doppia capacità, convenzionale e nucleare. Il Bunker Hill ha partecipato nel gennaio 2007 alle operazioni di bombardamento USA in Somalia in contemporanea all’ invasione del paese da parte delle forze armate etiopi. La proiezione della forza aeronavale nell’intero continente esalterà ulteriormente il ruolo assunto dall’US Southern Command - SOUTHCOM (il Comando Sud delle forze armate USA con sede in Florida), nella pianificazione della strategia politica e militare degli Stati Uniti verso l’America latina. Il Comando, in particolare, ha pubblicato nel 2007 un documento dal significativo titolo “US Southern Command - Strategy 2016 Partnership for the America”, in cui si delineano le ragioni e gli obiettivi della presenza militare statunitense nell’area per il prossimo decennio. Come evidenziato da Gabriel Tokatlian, docente di Relazioni Internazionali dell’Università San Andrés di Buenos Aires, si tratta del “piano strategico più ambizioso per la regione che sia mai stato concepito da diversi anni a questa parte da un’agenzia ufficiale statunitense”. Nelle pagine del report, SOUTHCOM si erge ad organizzazione leader, tra quelle esistenti negli Stati Uniti d’America, per assicurare “la sicurezza, la stabilità e la prosperità di tutta l’America”. Ampio il ventaglio degli obiettivi strategici da conseguire entro il 2016: tra essi, una “migliore definizione del ruolo del Dipartimento della Difesa nei processi di sviluppo politico e socioeconomico del continente”; la “negoziazione di accordi di sicurezza in tutto l’emisfero”; l’ attribuzione a nuovi paesi della regione dello status di alleato extra- NATO” (oggi lo è la sola Argentina); la “creazione e l’appoggio di coalizioni per eseguire operazioni di pace a livello regionale e mondiale”; l’identificazione di “nazioni alternative disponibili ad accettare immigrati” e “stabilire relazioni per affrontare il problema delle migrazioni di massa”. L’US Southern Command punta inoltre a sviluppare programmi continentali di “addestramento nel campo della sicurezza interna”; sostenere l’iniziativa di un “battaglione congiunto delle forze armate centroamericane per realizzare operazioni di stabilizzazione”; incrementare il numero delle cosiddette “località di sicurezza cooperativa” (si tratta di basi di rapido dispiegamento come quelle recentemente concesse alle forze armate USA dal governo colombiano di Uribe). In vista della riaffermazione egemonica delle forze armate USA in quello che da sempre viene considerato il “cortile di casa”, l’1 luglio 2008 è tornata ad essere operativa la IV Flotta dell’US Navy, disattivata dal Pentagono nel 1950. l quartier generale della IV Flotta è stato emblematicamente stabilito presso la stazione navale di Mayport, Florida, sede dell’US Southern Command, e il comando diretto della flotta è stato attribuito al comandante in capo dell’US Naval Forces Southern Command (NAVSO), la componente navale di SOUTHCOM. “La IV Flotta opera di concerto con le componenti navali, sottomarine ed aree, le forze di coalizione e le Joint Task Forces di SOUTHCOM in una vastissima aerea geografica comprendente i Caraibi, il Centroamerica e il Sud America”, spiega Washington. “Con lo scopo di rafforzare l’amicizia e la partnership con i paesi della regione, la IV Flotta supporta direttamente la Strategia Marittima USA, conducendo principalmente le missioni di appoggio alle operazioni di peacekeeping, l’assistenza medica ed umanitaria, il pronto intervento in caso di disastri, la realizzazione di esercitazioni marittime d’interdizione e di addestramento militare bilaterale e multinazionale, l’azione anti-droga, la lotta al terrorismo internazionale e al traffico di persone”. A conferma dell’obiettivo di “militarizzare” ogni aspetto civile, sociale e di “cooperazione”, si puntualizza che per la pianificazione e l’esecuzione delle proprie missioni, la IV Flotta opererà “accanto alle organizzazioni non governative, alle agenzie che rappresentano le nazioni partner e alle organizzazioni internazionali”. La riproposizione della politica delle cannoniere in Sud America e nei Caraibi risponde alla necessità di rafforzare il presidio delle rotte commerciali regionali, fondamentali per l’economia statunitense, e di protezione dell’accesso e del controllo delle grandi corporation sulle incomparabili risorse energetiche, minerarie ed idriche del continente. Il Pentagono non nasconde inoltre che le task force navali siano state costituite come forma di pressione politico-militare contro i governi più o meno progressisti che guidano ormai buona parte dei paesi del continente americano. La IV Flotta è risorta nel momento in cui si sono consolidate istanze di coordinamento politico, sociale ed economico regionale come Unasur, il Mercosur e l’Alba, ed è stato costituito il Consiglio di Difesa sud-americano, un organo di cooperazione tra le Forze Armate del continente che, tra ambiguità di fondo e latenti divisioni interne, ha tuttavia escluso la presenza statunitense. Come successo in Africa con la costituzione del nuovo comando delle forze armate USA che sovrintende a tutte le operazioni nel continente (AFRICOM), i processi di militarizzazione dell’America latina sono stati accelerati per rispondere alla penetrazione economica e finanziaria della Cina. L’intercambio bilaterale del gigante asiatico con il continente ha raggiunto nel 2007 la ragguardevole cifra di 100 miliardi di dollari. Dall’aprile del 2009 la Cina è divenuta la principale partner commerciale del Brasile, il paese sudamericano con il tasso di crescita più rilevante, scavalcando nettamente gli USA. La Cina si sta affermando inoltre come il principale mercato di esportazione del Cile, il secondo di Argentina, Perù, Costa Rica e Cuba, il terzo di Venezuela e Uruguay. I settori d’intervento sono molteplici: innanzitutto quello petrolifero (Pechino ha assicurato un prestito per 10 miliardi di dollari all’impresa petrolifera brasiliana Petrobras ed ha investito diverse centinaia di milioni di dollari nei giacimenti di Caracoles e dell’Orinoco in Venezuela e di Talara in Perù); il minerario (zinco in Perù, ferro in Brasile, rame in Cile); l’industria agroalimentare (Argentina), meccanica ed elettronica (ancora Brasile, Perù, Uruguay e Cuba). Durante il primo anno di vita della Zona Franca di Nueva Palmira, sul Rio Uruguay, dove sono convogliate alcune produzioni agricole e forestali di Argentina, Brasile meridionale e Paraguay, la Cina compare come maggiore paese di destinazione finale delle merci (oltre 560.000 tonnellate, il 31% del totale, in buona parte soia e cellulosa). Tra i prodotti di alta tecnologia esportati al continente latinoamericano, ci sono pure i sistemi di tele-sorveglianza dei centri urbani. Il governo frenteamplista uruguaiano ha affidato alla ZTE Corporation di Pechino una commessa di 12 milioni di dollari per la fornitura di telecamere a circuito chiuso da installare in porti, aeroporti, piazze e strade del paese sudamericano. Tra coloro che manifestano maggiore preoccupazione per l’avanzata economico-finanziaria cinese in America latina ci sono i manager dell’industria bellica statunitense. Sulla nota rivista del settore Air & Space Power Journal, nel novembre del 2006 è apparso un lungo articolo dedicato alla presenza del colosso asiatico in America Latina, la cui pericolosa conseguenza sarà “la trasformazione dei porti del Pacifico” e il “cambiamento nella struttura economica con la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero”. Ergo, gli estensori ribadivano il “diritto e il dovere” degli Stati Uniti di “vigilare sulle modalità con cui questo intervento si ripercuote nella salute pubblica, sociale ed economica dell’emisfero occidentale”. Roger Noriega, ex segretario di Stato per gli Affari dell’Emisfero Occidentale, ha dichiarato di fronte al Congresso che “gli Stati Uniti continueranno ad osservare da vicino la strategia cinese di avvicinamento all’America latina, in modo da assicurare che essa sia compatibile con il progresso registrato nella regione nell’affermazione della democrazia rappresentativa. Un progresso duramente guadagnato…”. Ulteriore elemento di preoccupazione per Washington, gli accordi di cooperazione nel settore militare sottoscritti dalla Cina con paesi della regione, in particolare quello che ha visto l’invio di personale militare venezuelano in Asia per la formazione nella gestione dei satelliti di telecomunicazione. Motivo di allarme tra gli strateghi statunitensi anche la crescente presenza di società della Cina nei porti di Balboa e Cristobal, nel Canale di Panama. “Queste compagnie sono controllate da cinesi comunisti che hanno ottenuto un bastione nel Canale senza sparare un solo colpo, cosa che invece è costata lunghi sforzi al nostro paese”, ha dichiarato qualche tempo fa il portavoce del Comando SOUTHCOM. Attraverso il Canale di Panama transita attualmente il 5% del commercio globale e più dei due terzi delle imbarcazioni sono dirette a porti degli Stati Uniti. Un’importanza economica destinata a crescere ulteriormente adesso che hanno preso il via i lavori di ampliamento del sistema di chiuse per consentire il transito a navi fino a 366 metri di lunghezza e 50 di larghezza, capaci di trasportare fino a dodicimila container, o alle petroliere in grado di stivare sino ad un milione di barili di greggio. I lavori nel Canale di Panama saranno completati entro il 2014 e costeranno più di 5,25 miliardi di dollari. Ad aggiudicarsi una porta sostanziale delle commesse un consorzio guidato dall’italiana Impregilo. Proprio nel Canale di Panama, meno di un mese fa si è tenuta una mega-esercitazione aeronavale (PANAMAX 2009) promossa dall’US Southern Command. “Un’ esercitazione insostituibile per continuare ad assicurare la difesa di questo corridoio strategico e prevenire un ampio spettro di possibili minacce, inclusi gli atti terroristici”, ha dichiarato il colonnello Michael Feil, comandante di US Army South e direttore delle operazioni aereonavali nel Canale. “Le organizzazioni terroristiche transnazionali hanno come obiettivo quello di influenzare i paesi e convincerli ad opporsi alla partnership con gli Stati Uniti d’America. Attaccando il Canale di Panama essi colpiranno i beni che vi transitano e incoraggeranno i paesi ad ascoltarli”. “PANAMAX tiene insieme i paesi che sono d’accordo a sostenere lo sforzo per la sicurezza del Canale”, ha concluso il colonnello Feil. “I paesi partecipanti ne riconoscono il ruolo e l’importanza nel mantenere gli standard di vita e l’economia dei popoli della regione”. All’importante esercitazione hanno partecipato 4.500 militari, 30 navi da guerra e decine di cacciabombardieri di Stati Uniti e venti nazioni straniere (Argentina, Belize, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana ed Uruguay). PANAMAX è stata l’occasione perché la IV Flotta USA potenziasse sul campo capacità e funzioni, sperimentando tecniche d’intervento contro la pirateria navale e l’uso di velivoli senza pilota UAV. A conclusione di PANAMAX 2009, la IV Flotta ha ottenuto la pre-certificazione di Maritime Operations Center MOC), il “congiunto di flessibilità e prontezza operativa”, necessari secondo la US Navy, per il “controllo delle missioni navali a livello bellico, d’intelligence, logistico e del settore delle telecomunicazioni”. “La IV Flotta – spiega SOUTHCOM - può condurre da oggi l’intero spettro delle operazioni di sicurezza marittima in appoggio agli obiettivi USA di cooperazione che promuovono la costruzione di alleanze e impediscono i tentativi di aggressione”.
http://www.coordinamentobolivariano.org
09/06 - PIEDAD CORDOBA: “GLI SFOLLATI IN COLOMBIA SONO 4 MILIONI E MEZZO!”
Dal Costa Rica, dove si trova in visita per cercare sostegno nella battaglia per una soluzione politica al pluridecennale conflitto sociale ed armato colombiano, la senatrice Piedad Córdoba ha rivelato che, in Colombia, gli sfollati interni sono ormai 4,5 milioni.
Riferendosi a questa agghiacciante cifra, che fa della Colombia il paese al mondo con il maggior numero di profughi interni (unitamente al Sudan), Piedad ha ricordato che è pari all’intera popolazione del Costa Rica stesso, e che solo negli ultimi sei mesi oltre 200.000 persone sono state cacciate dalle loro case, terre e regioni!
Nonostante il regime oligarchico di Bogotá si ostini a ripetere che lo sfollamento massivo è imputabile all’agire guerrigliero, oscillando tra il non riconoscimento dell’ampiezza e della gravità del fenomeno ed il meschino tentativo di togliere credibilità ai diversi rapporti che ne rendono conto (compreso quello annuale dell’ONU), le cause sono ben altre: la popolazione rurale viene espulsa con la violenza, per mano del paramilitarismo di Stato, da quelle regioni in cui vengono messi in cantiere megaprogetti delle multinazionali, o in cui vi sono risorse strategiche appetibili da sfruttare senza l’interferenza (ossia la presenza) di popolazioni “di troppo”. Per non parlare della storica tendenza all’allargamento manu militari dei latifondi (quasi sempre improduttivi), dinamica che beneficia l’oligarchia, massacra i piccoli contadini e sconquassa il già precario equilibrio ecologico.
La Córdoba, che è anche coordinatrice del movimento Colombianos por la Paz , ha inoltre ribadito da San José la necessità di perseverare nella ricerca di un accordo umanitario di scambio di prigionieri tra le parti belligeranti, osteggiato dal guerrafondaio Uribe. In merito alla liberazione unilaterale del sottufficiale Pablo Moncayo annunciata dalle FARC, in potere delle quali si trova da oltre undici anni, Piedad ha affermato che il processo “è bloccato perché il presidente esige che io esca dalla mediazione”, cosa inaccettabile per le FARC.
Del resto, se da una parte Uribe manda a morire sul campo di battaglia i soldati (quando i suoi figli, arricchitisi illecitamente grazie al padre, non hanno mai fatto un giorno di servizio militare), la cui vita disprezza quando cadono prigionieri dell’insorgenza, dall’altra li usa per terrorizzare e cacciare milioni di innocenti dalle loro terre, privandole di ogni forma di sostentamento.
07/06 - MINACCE DI MORTE A POLITICI E SINDACALISTI NELLA CITTA' DI BARRANQUILLA
Rappresentanti del Polo Democratico Alternativo e altri dirigenti minacciati di morte nella città di Barranquilla da gruppi di estrema destra, esigono che le autorità pubblichino il nome dell'autore dei pamphlet che sono circolati recentemente a firma di un presunto gruppo autonominatosi “Águilas Negras gaitanistas”.
La richiesta arriva, fra gli altri, dai dirigenti del PDA Alfonso Camerano Fuentes e Jesús Humberto Torres, e da rappresentati sindacali, pesantemente minacciati; a quanto afferma il documento presentato alle autorità, “Da martedì 2 giugno 2009, secondo quanto diffuso dalla stampa, esiste una nota informativa del Corpo Tecnico d’Investigazione della magistratura (CTI) con le prove ottenute per il chiarimento di questo gravissimo atto”; i dirigenti minacciati reclamano dunque al governo del distretto di Barranquilla, e particolarmente al Segretario degli Interni Guillermo Polo Carbonel, che nelle prossime ore riveli il contenuto della nota attraverso i media.
Alcune indiscrezioni affermano addirittura che a diffondere il pamphlet sia stato lo stesso giovane sindaco della città, Alex Char Chaljub, un paramilitare dal colletto bianco.
Si ripetono dunque in tutto il Paese le minacce contro dirigenti della sinistra e del movimento operaio e sindacale, a dispetto della tanto sbandierata “Sicurezza Democratica” del presidente Uribe, che non ottiene alcun risultato al di fuori della propaganda di regime, strombazzata dai media oligarchici. Lo stesso Uribe, sempre pronto a ripetere la menzogna secondo cui i gruppi paramilitari sarebbero stati “smobilitati”, che accusa qualunque oppositore di complicità con la guerriglia; infamia, questa, che equivale a mettere una lapide sulla testa di chi poi viene scientificamente ed immancabilmente trucidato dai suoi paras di Stato.
04/06 - SACERDOTE COLOMBIANO DENUNCIA AUMENTO DELLE MINACCE NEL PAESE
In merito alle recenti minacce del gruppo paramilitare “Águilas Negras” a settori sociali colombiani, Jorge Julio Mejía, sacerdote, direttore del Programma per la Pace del Centro di Ricerca ed Educazione Popolare (CINEP), ha denunciato che nel suo paese continuano “in modo estremamente allarmante le minacce” per mettere a tacere i leader popolari.
Ad una domanda specifica sui gruppi che portano avanti i ricatti, ha chiarito che l'attuale governo non vuole riconoscerne la matrice paramilitare affermando di avere disarmato questi gruppi, anche se in realtà si sono riciclati sotto diverse diciture.
Questo è proprio il caso delle “Águilas Negras”, emerse in seguito al cosiddetto processo di “smobilitazione” delle Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), che negli anni era arrivato ad essere il gruppo paramilitare più importante e crudele del paese sudamericano.
Dietro la facciata di un presunto “reinserimento civile”, molti di questi efferati criminali hanno continuato a massacrare impunemente, nel quadro di una politica controinsorgente di matrice oligarchica.
Il 27 maggio scorso le “Águilas Negras” hanno pubblicato sul loro sito una serie di minacce contro diversi dirigenti popolari, nonché categorie sociali che si muovono in un quadro di marginalità diffusa (prostitute, barboni, piccoli delinquenti, ecc.).
Di fronte a tutto ciò, Mejía ritiene che la paura si sia insinuata come un'arma utile a sottomettere la società colombiana, dal momento che ora non è più necessario uccidere, essendo sufficienti le minacce.
“Abbiamo un sentimento di indignazione etica” per il fatto che “ vogliono controllare questa nostra società mediante il terrore”.
Il sacerdote denuncia che l'intento di questi gruppi paramilitari è che “la gente non reclami i propri diritti; che, ad esempio, gli sfollati non reclamino la restituzione delle loro terre, che non accedano alla giustizia, che non testimonino contro nessuno”.
Ecco la farsa della “smobilitazione” delle AUC: il governo garantisce l'impunità alla maggior parte degli autori dei crimini più indicibili, comminando al più pene lievissime, scontabili agli arresti domiciliari o tramite programmi di reinserimento sociale; intanto i gruppi paramilitari cambiano nome ma certo né i metodi, né le ideologie, e proseguono nella loro opera al servizio dei latifondisti, dell'oligarchia, delle multinazionali e dei politici colombiani. Il presidente Uribe, da sempre colluso con i paramilitari, ha confezionato una legge su misura per i suoi vecchi amici, che non tardano a ricambiargli il favore continuando a minacciare gli oppositori sociali e favorendo le sue campagne elettorali.
02/06 - LA MONARCHIA SPAGNOLA E’ COMPLICE DEL TERRORISMO DI STATO IN COLOMBIA
Nel quadro del governativo e destroide “V Congresso internazionale delle vittime del terrorismo”, promosso dal governo colombiano e da altri settori reazionari di diversi paesi e tenutosi negli ultimi giorni a Medellín, non poteva mancare un degno rappresentante della franchista casata borbona, il principe delle Asturie Filippo.
Costui, erede al trono di una delle più vetuste e criminali monarchie ancora vigenti, si è speso in complimenti e non ha lesinato parole di sostegno al regime mafioso e paramilitare di Alvaro Uribe Vélez.
Filippo, con le trite e ritrite menzogne spesso vomitate dallo stesso re Juan Carlos, ha affermato che “sono assai noti ed internazionalmente riconosciuti i risultati ottenuti dalla Colombia nello sradicamento della violenza...”, e che “la lotta contro il terrorismo, contro il narcotraffico ed a favore dei più solidi principi democratici potrà sempre contare sul sostegno fermo e definito della Spagna”.
Don Felipe dimentica che in Colombia il terrorismo è incarnato dallo Stato e dai suoi paramilitari, il narcotraffico è un business capitalista in cui un ruolo centrale è giocato dalle oligarchie e dai poteri forti (vero famiglia Santos?), e i più solidi principi democratici sono stati sterminati col genocidio dell’Unión Patriotica.
Sfoggiando presunti valori morali che non gli appartengono, Felipe delle Asturie ha inoltre affermato che “non c’è denaro al mondo che sostituisca una vita che è stata strappata, o che risarcisca del tutto le lesioni fisiche o psicologiche prodotte, né la perdita di libertà e sicurezza”. Si riferiva evidentemente alla questione del risarcimento delle vittime, ma anche qui soprassedendo al fatto che il vero vittimario è il regime carnefice di Uribe che i Borboni ammirano ed appoggiano tanto.
In quanto a “valori” e “morale” l’erede al trono di una giurassica dinastia, sempre in prima fila nell’opprimere e neocolonizzare popoli di diverse latitudini (a iniziare da quello basco), non ha il diritto di sputare sentenze e filippiche. Piuttosto, Filippo farebbe meglio a chiedersi fino a che punto sia conveniente andare a braccetto con la cosca mafiosa che governa la Colombia.
ORDINATO L'ARRESTO DI UN GOVERNATORE PER LEGAMI CON PARAMILITARI.
La magistratura colombiana ha ordinato la detenzione del governatore del dipartimento del Guaviare, Óscar López, per presunti legami con i paramilitari.
Secondo l'agenzia tedesca Dpa il capo dell'ente accusatore, Mario Iguarán, ha spiegato che "poiché si tratta di un governatore in carica, lo stesso Procuratore Generale ha sollecitato il presidente Álvaro Uribe Vélez affinché procedesse alla
sospensione dell'incarico". Il funzionario ha richiesto che si indaghino le connessioni del mandatario dipartimentale con la società di Esplorazione ed Esportazione Mineraria del Llano, della quale è azionista Pedro Guerrero, alias "Cuchillo", un noto narcotrafficante. "Il governatore è indagato per associazione a delinquere aggravata", secondo quanto afferma un comunicato della Procura, che precisa che contro López è stato emesso un ordine di detenzione preventiva senza il beneficio di scarcerazione. López è accusato di aver avuto legami col paramilitare Vicente Castaño, alias “El Profe” e con "Cuchillo", uno dei quattro signori della droga più ricercati in Colombia.
Ancora una volta si dimostra incontenibile lo scandalo della para-politica, e si palesano i vincoli tra i politici di tutti i livelli ed il paramilitarismo. Questa macabra simbiosi, tutt’altro che all’epilogo, rende ancor più illegittimo ed illegale il mafioso regime colombiano, e tutte le sue articolazioni di governo e di potere locali.
MINACCE PARAMILITARI AL CANALE EUROPEO “ARTE” ED ALLA TELEVISIONE SVIZZERA
Un articolo pubblicato sul giornale svizzero Le Courrier e firmato dal giornalista Benito Pérez, il 3 marzo scorso, ha reso noto che giornalisti europei sono stati vittime di minacce in Colombia da parte dei paramilitari. Alcuni giornalisti svizzeri, che si trovavano in Colombia per realizzare un documentario sull’impunità, sono stati minacciati di morte da un gruppo autodenominato “i veri colombiani”, un chiaro riferimento alla concezione uribista secondo cui chi denuncia i crimini del terrorismo di Stato, starebbe in realtà “parlando male della Colombia” all’estero, diventando così un “traditore della patria”. Il giornalista Juan Lozano (vincitore del premio al miglior documentario svizzero al festival 2008 “Visione del reale” di Nyon), ha denunciato che la troupe congiunta del canale ARTE e della TSR svizzera, da lui diretta, ha dovuto interrompere le riprese ed abbandonare precipitosamente la Colombia a causa delle minacce. I giornalisti europei, che hanno sperimentato sulla propria pelle il clima di caccia alle streghe nei confronti di chi informa in modo critico sulla realtà colombiana, hanno presentato una denuncia presso un tribunale di Ginevra, che ha aperto un’inchiesta. Diversi comunicatori sociali, giornalisti indipendenti e non allineati al regime (come William Parra, Freddy Muñoz, Carlos Lozano, Hollman Morris, Jorge Enrique Botero ed Alfredo Molano, tra gli altri) hanno sofferto e subiscono attualmente la persecuzione da parte dello Stato colombiano; a differenza dei pennivendoli dei grandi media dell’oligarchia come RCN, Caracol, El Tiempo, La W Radio, ecc., che si autocensurano o partecipano alla patetica stesura dei metaracconti sulla Colombia virtuale, fatta di “democrazia” (che non esiste) e di
“vittorie sensazionali” sul cosiddetto “terrorismo” (che sono solo pirriche), tanto per citare alcuni dei deliri onirici del guerrafondaio Uribe.
LE CIFRE RACCAPRICCIANTI DEL TERRORISMO DI STATO IN COLOMBIA
In base a dati recenti di diverse organizzazioni di difesa dei diritti umani e dei familiari delle vittime del terrorismo di Stato, nonché della stessa Fiscalia (la magistratura colombiana), i casi di “falso positivo” finora conclamati sono 1200. Migliaia di parenti, amici e vedovi/e piangono questa pratica assassina delle forze repressive del regime colombiano, che, dopo aver sequestrato con l’inganno o con la
forza giovani di tutto il Paese, averli portati altrove ed averli ammazzati a sangue freddo, li hanno vestiti con uniformi militari per poi presentarli come “guerriglieri abbattuti in combattimento” (sic!)
Mentre il ministro della guerra JM Santos ed il presidente paramilitare Uribe si affannano a dire che i “falsi positivi” sono semplicemente casi isolati di poche mele marce all’interno delle forze armate, addirittura lo stesso ex presidente Andrés Pastrana ha riconosciuto che i “falsi positivi” non potrebbero non essere definiti come “crimini di Stato”.Sempre in base ai suddetti dati, negli ultimi dieci anni sono stati fatti sparire oltre 1500 sindacalisti, la maggior parte dei quali risulta desaparecida a partire dal 7 agosto 2002 (data dell’insediamento alla presidenza di Uribe Vélez).
Come se non bastasse, sono stati sequestrati dal terrorismo di Stato anche 22 leaders dei familiari delle vittime del paramilitarismo (politica dell’oligarchia ai interrotta, checché ne dica il governo che blatera di una fantomatica “smobilitazione” dei suoi squadroni della morte). La strategia di colpire in diversi modi i familiari delle vittime (che lo diventano a loro volta), al fine di zittirli e di mettere una museruola di piombo alle denunce contro il terrorismo di Stato, é diretta dalla cupola narco-mafiosa che é al governo e dalle sue forze militari, carnefici del popolo colombiano.
LETTERA DEI “COLOMBIANI E COLOMBIANE PER LA PACE”
AL COMANDANTE DELLE FARC-EP, ALFONSO CANO

Signor Alfonso Cano, Comandante delle FARC-EP
Membri del Segretariato
Montagne della Colombia
Vi giunga il nostro saluto di speranza in una pace duratura.
Noi, “Colombiani e Colombiane per la Pace”, reiteriamo la nostra volontá di portare avanti il processo d’interscambio epistolare con le FARC.
Riconosciamo la volontá di questa guerriglia, del CICR e del governo del Brasile, cosí come l’accettazione da parte del governo nazionale, affinché la liberazione di quattro membri della forza pubblica e di due dirigenti politici avesse un epilogo felice.
Tali liberazioni costituiscono un riferimento positivo per il necessario processo di soluzione negoziata che permetta di porre fine al conflitto sociale ed armato interno, per vie diverse da quelle della guerra.
Come abbiamo fatto sin dall’inizio di questo dialogo epistolare, rifiutiamo e condanniamo le pratiche contrarie ai piú elementari principi umanitari, e confidiamo che gesti come quello delle recenti liberazioni portino in breve tempo ad un riconoscimento esplicito del fatto che la degenerazione del conflitto sta disarticolando politicamente e moralmente la societá colombiana; e che ció sfoci in una franca, decisa e definitiva proscrizione delle pratiche lesive dei valori umanitari piú basilari. Reiteriamo la nostra preoccupazione in merito alla disponibilitá o meno delle FARC di escludere, dal conflitto armato, il sequestro come arma di lotta.
Un primo passo in questa direzione é, senza dubbio, l’apertura ad un accordo umanitario, contenuta nei vostri piú recenti comunicati. E’ indispensabile puntualizzare, con urgenza, la cornice all’interno della quale si potrebbe concretizzare un tale accordo, stabilendo le circostanze di tempo, modo e luogo, in modo che noi si possa contribuire alla sua rapida realizzazione. A nostro giudizio, tale meccanismo deve dare inizio alla ricerca di alternative per porre fine al conflitto. Questo accordo, oltre all’interscambio, deve propiziare negoziati politici che portino al conseguimento della pace, come supremo anelito della societá.
Ci proponiamo di portare avanti il nostro appoggio all’accordo umanitario, nei termini segnalati, ed alla costruzione di spazi adeguati per rendere effettivo il diritto costituzionale alla pace.
Cordialmente,
Colombiani e Colombiane per la Pace
IL CONGRESSO COLOMBIANO APPROVA IL PROGETTO DI RIELEZIONE DI URIBE
La Camera colombiana ha approvato il Referendum per la modifica costituzionale - che permetterebbe la rielezione del presidente Uribe- con il voto favorevole di 86 parlamentari, appartanenti alla coalizione uribista, e l'astensione dell'intera opposizione, che considera illegale la seduta straordinaria dei Rappresentanti e ne denuncia l'irregolarità per i dubbi sul finanziamento della campagna per la raccolta delle firme che appoggiano il progetto di referendum.
Il progetto, che dovrà passare ora al Senato, prevede la possibilità della rielezione solo a partire dal 2014; tuttavia, assicura Fabio Valencia, ministro degli interni (nonché ex ambasciatore a Roma, ed inquisito per rapporti con i paralamitari; cfr. anche Clamores 8), il testo potrà essere modificato per permettere la rielezione immediata.
Come sempre, nessuno dei grandi media nazionali e internazionali sembra avere nulla da ridire sulla possibile rielezione di un narcotrafficante coinvolto in decine di scandali, eletto per mezzo delle pressioni dei paramilitari, del voto di scambio, del voto di elettori morti.
FARC-EP: RIAPERTURA PAGINA WEB
Apprendiamo dalla stampa alternativa che la pagina web delle FARC-EP è nuovamente in linea. Dopo aver affrontato diversi attacchi dovuti alla guerra tecnologica e inconvenienti tecnici, la voce dell’insorgenza ritorna in rete. Il nuovo indirizzo è: http://www.farc-ejercitodelpueblo.org/.
La possibilità di poter entrare a conoscenza delle proposte avanzate dalla controparte belligerante, rispetto alla propaganda governativa che abbonda su tutti i mezzi di comunicazione, aiuta a comprendere le problematiche di un conflitto sociale, politico ed armato che si protrae da oltre cinquant’anni e le cui cause ancora restano irrisolte.
ESERCITO E PARAMILITARI PROVOCANO OSTILITA’ ALLA FRONTIERA CON L’ECUADOR.
In un comunicato delle FARC-EP, datato 12 dicembre, l’organizzazione guerrigliera denuncia all’opinione pubblica nazionale ed internazionale il tentativo da parte del governo uribista di coinvolgere nel conflitto colombiano il confinante paese dell’Ecuador. Membri dell’Esercito della Colombia ed alcuni ufficiali ecuadoregni della Marina, al comando di proprie unità, contravvenendo alle direttive imposte dal Presidente Correa, hanno realizzando pattugliamenti congiunti sui fiumi San Miguel e Putumayo. Alcune incursioni in territorio ecuadoriano da parte di militari e paramilitari colombiani sono state compiute per assassinare e sequestrare a nome della guerriglia con l'intento di destabilizzare l'area.
Ribadendo la completa estraneità ai fatti in questione, l’insorgenza conferma la propria determinazione politica al rispetto delle frontiere e denuncia l'ennesima messa in scena di Uribe come la fotocopia di quello già messo in atto in Venezuela, dove l’infiltrazione di paramilitari ha come obiettivo la caduta del governo di Hugo Chávez. I settori uribisti stanno mettendo in pratica le direttive della CIA: instaurare il caos nella regione per frenare i processi democratici e l’unità dei popoli bolivariani.
L’IMPUNITA’ IN COLOMBIA HA IL POLLICE VERDE
Miguel De la Espriella, para-politico agli arresti nel penitenziario La Picota di Bogotà, ha potuto godere di un notevole sconto di pena per il lavoro svolto in carcere. Infatti la legge colombiana stabilisce che per ogni due giorni in cui un detenuto studia o lavora, gli si sconti un giorno di pena. De la Espriella ha fatto di più; in virtù del dono dell’ubiquità è riuscito a fare entrambe le cose, grazie a “corsi trasversali” come quello dedicato all’agricoltura biologica o quello relativo all’allevamento dei bovini. Tutto rigorosamente certificato dai funzionari del carcere.
Evidentemente non era sufficiente la legge “Justicia y Paz”, che limitava la pena ad otto anni di reclusione per i crimini di lesa umanità compiuti dai paramilitari; ora per i veri capi delle squadracce della morte è arrivato il giardinaggio a garantire l’impunità; tra lattuga, pomodori e lavori di pulizia, questi mafiosi lavano le loro mani sporche del sangue di migliaia di oppositori politici. Alle vittime del paramilitarismo di fatto non viene garantita nessun tipo di riparazione, mentre ai para-politicanti viene garantita l’impunità totale; oltre al danno, la beffa!
TOUR DI INGRID BETANCOURT IN AMERICA LATINA
Ingrid Betancourt ha compiuto un serie di visite in alcuni paesi Sud Americani: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, Perù e Venezuela, per ringraziare i rispettivi presidenti che si sono impegnati per la sua liberazione. Durante i vari incontri con i capi di Stato ha più volte ribadito che la guerriglia delle FARC deve porre in libertà, e senza condizioni, i prigionieri di guerra che restano detenuti nella selva Nessun accenno alla chiusura del presidente Uribe rispetto ad un accordo umanitario sullo scambio, ne tantomeno ai prigionieri di guerra in mano allo Stato colombiano.
Con un linguaggio molto somigliante a quello adoperato dal governo, ha bollato l'insorgenza con i soliti epiteti, tralasciando temi centrali come quelli della violazione dei Diritti Umani, le numerose proteste indigene, contadine e studentesche, nonché le truffe architettate ai danni dei piccoli risparmiatori. La Betancourt è stata favorevole al Plan Colombia, applaude il riscatto a ferro e fuoco di Uribe e qualcuno vorrebbe persino candidarla al Nobel per la Pace. Visto che ha dichiarato che non si candiderà alle prossime elezioni presidenziali in Colombia poiché la politica nel "suo paese" è corrotta, e quindi non da nessun tipo di contributo ad una soluzione politica e negoziata, questo sembra essere più un viaggio diplomatico organizzato dalla Casa de Nariño.
E-MAIL INESISTENTI NEL COMPUTER DI RAUL REYES
Il responsabile del dipartimento scentifico della DIJIN (Direzione Polizia Giudiziaria colombiana), il capitano Ronald Coy Ortiz, ha dichiarato sotto giuramento alla Magistratura Gnerale della Nazione, che nel computer del comandante delle FARC Raúl Reyes non esiste alcuna corrispondenza di posta elettronica, ma unicamente fogli elettronici in formato "Word". Il Ministro della Difesa, Juan Manuel Santos, invece afferma che vi sarebbero numerose e-mail, contraddicendo grottescamente coloro che hanno lavorato materialmente sul notebook.
Appare sempre più chiara la manipolazione attuata dal governo di Uribe ai danni di vari capi di Stato latinoamericani, politici nazionali ed internazionali, intellettuali e difensori dei Diritti Umani, nel tentativo maldestro di criminalizzarli e azzittirli. Le magistrature di vari paesi dell'Unione Europea, che sulla base di queste prove falsificate avevano a suo tempo emesso vari provvedimenti cautelativi, dovranno prendere delle concrete contromisure verso un governo che, anche nella facciata, dimostra essere totalmente illegittimo e privo di credibilità.
CONTINUA LO STERMINIO DI LEADER POPOLARI COLOMBIANI ALLA FRONTIERA COLOMBO-VENEZUELANA
Venerdì 28 novembre, verso le sette della sera, è stato assassinato da alcuni sicari nel quartiere Guadual de Arauquita - dipartimento di Arauca, Colombia - il leader popolare dell'omonimo dipartimento, Carlos Rodolfo Cabrera nella zona limitrofa allo stato venezuelano di Apure.
I comitati per la difesa dei diritti umani nella regione denunciano davanti alla opinione pubblica nazionale e internazionale l'omicidio di Cabrera, portavoce del comitato degli sfollati di Araquita, che aveva anche ricoperto il ruolo di segretario esecutivo dell' Associazione Contadina di Arauca (ACA). Gli era stata accordata la protezione della Commissione Interamericana dei Diritti Umani, e per la persecuzione di cui l'ACA era stata oggetto, il programma di protezione governativa. Era anche sopravvissuto al genocidio dell'Unión Patriótica.
La zona di frontiera è un luogo dove la presenza di paramilitari ha raggiunto livelli altissimi, e dispone di punti d'appoggio politici nel territorio. Il governo colombiano è il primo complice di questi terroristi, e non ha alcun interesse nel contrastarli; è troppo impegnato ad occuparsi dei problemi interni del paese vicino!
STUDENTESSA SUPERSTITE DEL BOMBARDAMENTO IN ECUADOR RITORNA IN PATRIA
Lucía Morett, l'unica superstite del gruppo di studenti messicani che si trovavano nell'accampamento provvisorio delle FARC in Ecuador, è rientrata in patria. Dopo che ha dovuto forzosamente ricorrere all'asilo politico in Nicaragua, a causa della criminalizzazione del governo colombiano e di alcune organizzazioni di estrema destra messicane che pretendevano perseguitarla ed incarcerarla, resta appurato il fatto che i giovani studenti non appartenevano alla guerriglia, bensì stavano compiendo attività strettamente accademiche. Nel bombardamento dell'Esercito colombiano vennero assassinati Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Soren Avilés Ángeles e Juan González del Castillo.
Lucía Morett ha ricevuto la solidarietà di molte organizzazioni messicane ed internazionali ed un calorosa festa di benvenuto presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM). Sicuramente il governo del narco-paramilitare Uribe e i suoi sbirri sparsi per il continente, non desisteranno nella persecuzione di coloro che credono in una soluzione politica e pacifica del conflitto, ma troveranno sempre mille voci che si leveranno per denunciare uno Stato criminale che viola sistematicamente i Diritti Umani e i Trattati Internazionali.
URIBE SBARRA LA STRADA ALL'ACCORDO UMANITARIO
Il presidente Álvaro Uribe Vélez, durante l'insediamento del Consiglio Comunale di Governo, ha dichiarato che il suo governo non accetta l'intermediazione di una nota dirigente politica colombiana con le FARC, per trovare un accordo sullo scambio umanitario dei prigionieri di guerra. Benché non abbia pronunciato il suo nome, è chiarissimo che si riferiva alla senatrice Piedad Córdoba la quale, unitamente ad un folto gruppo di intellettuali, ha impulsato uno scambio epistolare con la guerriglia, come l'inizio di un percorso che potrebbe portare alla liberazione dei detenuti in mano alle due parti belligeranti. Uribe ha ribadito l'appoggio alla Forza Pubblica per il riscatto manu militari dei prigionieri asserendo, sempre riferendosi allo scambio, che "non lo accettiamo".
Con il solito linguaggio arrogante in perfetto stile mafioso, Uribe ha tacciato l'insorgenza con i soliti termini calunniosi; tipici di coloro che, non avendo argomentazioni e proposte credibili, sguazzano nella loro impotenza. Il riscatto a ferro e fuoco non potrà che produrre un bagno di sangue, dato che le varie "liberazioni" avvenute nell'anno in corso sono frutto del tradimento e della delazione; non certo della capacità militare di riscattare i prigionieri. Solo un accordo umanitario permetterà ai detenuti di entrambe le parti di ritrovare la libertà e magari aprire la strada ad un Governo di Ricostruzione e Riconciliazione Nazionale, che ponga fine a oltre 50 anni di conflitto.
LANCIATA LA RED RADIAL BOLIVARIANA
Il 13 dicembre a Stoccolma sono state presentate la Rete Radiofonica Bolivariana e l'Associazione Bolivariana dei giornalisti; significativamente, la sede è quella del famoso Kafe Marx, dove era solito riunirsi Lenin durante il suo esilio in Svezia.
I suoi fondatori si pongono l'obiettivo di approfondire i processi democratici in America latina e in altre parti del mondo, consapevoli del ruolo strategico che giocano i mezzi d'informazione non allineati sulle posizioni imperialiste, e citano l'esempio positivo di alcuni media alternativi venezuelani ed ecuadoriani come Radio Bemba e Radio Luna. Hanno già aderito al progetto l'Agenzia di Notizie Nuova Colombia (ANNCOL), l' Agenzia Stampa Bolivariana (ABP), la radio svedese Cafè Stereo ed altri media internazionali.
L'ideologia che sta alla base della linea editoriale è quella del socialismo bolivariano, che coniuga le idee del Libertador, Simòn Bolìvar con la teoria marxista-leninista.
http://redradialbolivariana.net/
http://anncol.eu/images/nuevasBilder/red_bolivariana.jpg
RITIRATO IL CONSOLE COLOMBIANO A MARACAIBO
Il ministro degli Esteri venezuelano, Nicolàs Maduro, ha reso noto che il suo omologo colombiano, Jaime Bermúdez, ha annunciato domenica 30 novembre il ritiro del console generale di Maracaibo, Carlos Galvis Fajardo, su sollecitazione del presidente Chàvez.
Il giorno prima il conduttore televisivo Alberto Nolia aveva trasmesso la registrazione di una conversazione fra il console e José Obdulio Gaviria, cugino del defunto narcotrafficante Pablo Escobar, del cartello di Medellin, e attualmente assessore del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Secondo Nolia, Gaviria è anche responsabile della "smobilitazione" dei gruppi paramilitari delle AUC e la loro riorganizzazione nel gruppo delle "Aquile Nere".
Nella registrazione il console informa Gaviria sui dati parziali all'atto della conta dei voti delle elezioni amministrative, e afferma testualmente : " le due persone [in vantaggio nella competizione elettorale] sono nostri ottimi amici e penso che per il nostro lavoro di lì questo sia meraviglioso [...] abbiamo agguantato strategicamente stati e municipi come quello di Caracas e quello di Miranda".
La registrazione mette in luce l'intromissione nei problemi interni del Venezuela da parte della rappresentanza diplomatica colombiana, e rivela quanto diversi analisti denunciano da tempo, ovvero che l'opposizione antichavista, quantomeno nelle regioni al confine con la Colombia, è collusa con i gruppi politici narco-paramilitari colombiani. Il tentativo, come in Bolivia, è quello della destabilizzazione territoriale, provocando e alimentando spinte secessioniste di alcune regioni nei paesi dai governi progressisti dell'area.
INQUISITO IL MINISTRO DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA FABIO VALENCIA COSSIO
La procura generale della Colombia ha aperto un'inchiesta preliminare sul Ministro degli Interni e della Giustizia Fabio Valencia Cossio, per accertare se nel 1995 abbia cercato l'appoggio politico dei paramilitari.
A sostegno di questa ipotesi una lettera, scritta in quell'anno all'allora capo paramilitare Ramòn Isaza, in cui si segnalava che alcuni emissari di Valencia (all'epoca senatore) avevano sollecitato il suo appoggio affinché fosse eletto alla presidenza del direttorio del partito Conservatore.
In tal senso, il ministro colombiano ha affermato in un comunicato che in diverse occasioni Isaza ha dichiarato di ignorare in che modo sia stata inviata la lettera e che, benché sia sua la firma che appare in calce, questa può essere stata falsificata.
E' forse utile ricordare che il ministro Valencia, ex ambasciatore in Italia, ha un fratello agli arresti domiciliari per collusione con la mafia narcotrafficante.
Continuano le dimostrazioni degli intrecci fra narco-paramilitari ed esponenti del governo e della diplomazia colombiana, nel silenzio complice dei grandi media e della cosiddetta "comunità internazionale". Fino a quando?
FUORI IL MOSSAD DALLA COLOMBIA!
A
sessant’anni dalla nascita/imposizione dello Stato d’Israele,
assistiamo ad uno dei più terrificanti e meticolosi genocidi che la
storia contemporanea abbia mai partorito: quello ai danni del popolo
palestinese per mano del sionismo e dei suoi complici internazionali. I
popoli arabi in particolare e del mondo in generale conoscono e
condannano il ruolo illegittimo e criminale d’Israele nella regione
mediorientale, teatro d’interessi strategici e cruenti conflitti che
condensano tutte le contraddizioni tra imperialismo ed antimperialismo,
politiche neocolonizzatrici e lotte di liberazione nazionale.
Ciò che
spesso è meno noto all’opinione pubblica, è il ruolo degli apparati
sionisti in altre aree del pianeta, a partire dall’America Latina e dal
paese in cui, all’interno di essa, maggiore è il livello di scontro tra
le forze popolari e rivoluzionarie e l’imperialismo: la Colombia.
La
Colombia, paese che vive un conflitto sociale ed armato da oltre 50
anni e dove la presenza di immense risorse naturali e materie prime
rappresenta un obiettivo irrinunciabile per le grandi compagnie
multinazionali statunitensi (ma non solo), è governata da un’oligarchia
tanto sanguinaria quanto asservita ai dettami della Casa Bianca. Nella
guerra sporca e di bassa intensità articolata dal Pentagono in Colombia
fin dagli anni ’50, il ruolo di mercenari ed apparati israeliani è
stato tutt’altro che di second’ordine. Ad esempio, negli anni ‘80 unità sioniste contribuirono a addestrare i gruppi paramilitari, strumento del terrorismo di Stato. Uno dei comandanti di quelle unità era l’ex colonnello delle forze speciali israeliane Yair Klein, mercenario di professione e titolare della società di sicurezza “privata” Spearhead Ltd.
Nonostante un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol,
costui scorrazzava liberamente tra gli Stati Uniti e il suo paese
d’origine, muovendosi indisturbato per il mondo (Messico, Sierra Leone,
Asia, ecc.) grazie ai servizi resi ai due rispettivi governi
imperialisti. Klein
(al pari dei suoi compari israeliani Teddy Melnick, Miram Nir, Arik
Afek, Izhack Meraiot e Auraam Tzedaka) non era un cane sciolto,
nonostante si presentasse come un “libero battitore” nel settore della
sicurezza privata; era l’uomo-chiave mandato da Israele per elevare
qualitativamente la presenza del Mossad in Colombia, oltre che per
formare -su richiesta dell’Esercito colombiano- i paras in tecniche di tortura ed eliminazione degli oppositori al regime (ad esempio squartando le vittime con la motosega).
Dal
2005 Israele è tra i primi fornitori di armi alla Colombia, la quale
destina il 65% della spesa pubblica alla guerra, tanto che l’80% dei
funzionari e dipendenti pubblici lavorano nel settore militare e della
difesa. Con un investimento di oltre 160 milioni di dollari il Ministro della Difesa, Juan Manuel Santos, ha recentemente firmato un contratto con Israele per l’acquisto di 24 aerei supersonici da guerra K-FIR, che andrebbero
a potenziare l’azione militare contro una guerriglia delle FARC che le
forze armate del regime colombiano, pur avendo con il Plan Colombia
triplicato il numero dei loro effettivi e lanciato giganteschi
operativi militari, non riescono a sconfiggere.
La stretta e tenebrosa
collaborazione tra Tel Aviv e Bogotá, che riguarda anche tecnologie di
punta satellitari, sofisticate apparecchiature elettroniche nel campo
delle telecomunicazioni e la trasmissione e condivisione di dati d’intelligence,
aumenta nella misura in cui lo stato colombiano gioca ogni giorno di
più il ruolo “d’Israele dell’America Latina”, assegnatogli dagli USA
nella destabilizzazione/ aggressione ai danni del Venezuela bolivariano e degli altri processi progressisti e rivoluzionari nel continente. Per
questa ragione, il nemico dei popoli palestinese e colombiano è comune,
e si chiama imperialismo sionista. Anche per questo i vincoli di
solidarietà internazionalista e stima reciproca tra le resistenze dei
due popoli sono storici, e al tempo stesso più vivi che mai.
Esprimiamo
con determinazione la nostra solidarietà al popolo palestinese che da
oltre 60 anni subisce l’aggressione israeliana, condanniamo con forza
l’occupazione dei territori e i continui raid che assassinano sempre
più civili, in prevalenza donne e bambini.
- Solidarietà ai combattenti palestinesi e
colombiani! - Fuori l’imperialismo sionista dal Medio Oriente e dall’America Latina!
; Associazione nazionale Nuova Colombia
www.nuovacolombia.net
FARC-EP: COMUNICATO SULLA MORTE DI IVÁN RÍOS
1. Informiamo
l’opinione pubblica nazionale ed internazionale che all’alba del 7
marzo è stato assassinato da infiltrati dall’esercito, insieme alla sua
compagna, il Comandante e membro del Segretariato Iván Ríos. Con un
gesto che riflette il degrado della guerra, gli assassini hanno
tagliato la mano destra del Comandante per presentarla come trofeo e
prova della loro azione al colonnello della VIII Brigata dell’esercito,
quale macabra esigenza dei comandi militari colombiani imparentati con la motosega. Per
coprire questo codardo e vile assassinio, il Procuratore Generale Mario
Iguarán, con impudico cinismo, pretende di collegarlo ad un atto di
legittima difesa.
2. Rendiamo
un sentito tributo al Comandante guerrigliero sventolando la bandiera
del socialismo bolivariano. I nostri non muoiono al momento del loro
decesso, giacché continuano a vivere nel progetto politico e sociale
delle FARC e nell’anelito di pace e dignità del popolo. Iván Ríos era
entrato nel V Fronte nella regione dell’Urabá negli anni ’80. Ha
trascorso la sua vita guerrigliera forgiando coscienze ed organizzando
il popolo; nel 2000 aveva fatto parte, con capacità ed all’altezza del
compito, della Commissione Tematica dei dialoghi nel Caguán, e dal
novembre 2003 era diventato membro del Segretariato delle FARC,
rimpiazzando l’indimenticabile Efraín Guzmán. Coerente col suo
giuramento, Iván Ríos ha dato la vita per la causa dei poveri.
3. Condanniamo
l’accanimento del presidente della Colombia e dei comandi militari sui
cadaveri dei loro avversari abbattuti. A Iván Ríos hanno tagliato una
mano, e Raúl Reyes è stato insultato da morto, durante il Vertice di
Río a Santo Domingo, dal presidente che adesso non vuole consegnare i
suoi resti funebri. La viltà dello Stato rende più grande la nobiltà
dei nostri. Hanno paura addirittura dei cadaveri dei guerriglieri
bolivariani del secolo XXI, i quali sentono come proprie le lotte dei
popoli del continente che fanno parte dell’eroica resistenza contro la
spoliazione neoliberale della Nostra America, e che non muoiono perché
continuano a sognare insieme ai loro compagni ed al popolo la Nuova Colombia, la Patria Grande ed il Socialismo.
4. La
guerra che conduciamo è giusta perché è contro l’oppressione, per la
vita, la pace, la sovranità popolare e la giustizia sociale. Non
importano i milioni e milioni di dollari che il governo degli Stati
Uniti elargisce a quello colombiano per finanziare la guerra, se siamo
decisi a trionfare.
5. Informiamo
il nostro popolo e la comunità internazionale che il Comandante
Mauricio Jaramillo è stato designato come nuovo membro del Segretariato
delle FARC.
Vinceremo!
Segretariato dello Stato Maggiore Centrale delle FARC-Esercito del Popolo
Montagne della Colombia, 8 marzo 2008
E’ MORTO UN RINNEGATO E TRADITORE DEL POPOLO COLOMBIANO!
Alias Bernardo Gutiérrez en reunión del PDA en Roma (Italia)
Solo
alcuni mesi fa, quando nel corso di un’iniziativa sui diritti umani in
Svezia la dirigente popolare Aída Avella, sradicata dalla Colombia a
colpi di bazooka dall’intolleranza del regime borghese colombiano,
segnalò la presenza nelle fila del Polo Democratico dell’assassino di
appartenenti all’Unión Patriótica ed ex EPL BERNARDO GUTIERREZ ZULUAGA MORENO,
molti dei “ravanelli” (rossi di fuori e bianchi di dentro) di questo
minestrone indigesto e smemorato si sono strappati le vesti in difesa
del criminale in questione.
Seppur
tardi, nella sua saggezza la natura lo ha tolto di mezzo sabato scorso
(23 febbraio), applicando giustizia per i crimini che questo soggetto
commise quando, in alleanza col narcotrafficante e fondatore dei gruppi
paramilitari Vicente Castaño Gil, bagnò le terre di Córdoba e
dell’Urabá antioqueño col sangue di umili ed innocenti membri
dell’Unión Patriótica e del Partito Comunista Colombiano.
Questo
voltafaccia e traditore, che ricopriva il ruolo di direttore del Polo
Democratico Alternativo (PDA) in Italia, dove appariva come
pseudo-intellettual e e democratico, dalle comodità del suo
auto-esilio e godendosi una lauta provvigione quale ex funzionario
diplomatico, dedicava le poche ore rimastegli della sua spregevole
esistenza a realizzare estese diatribe sulla pace in Colombia.
Alias
Bernardo Gutiérrez, faccia di bronzo fin da giovane, aveva dimostrato
sin dai suoi primi passi politici le sue vere intenzioni. Nel suo
passaggio per le FARC,... uomini come Sergio Fajardo (ex sindaco
di Medellín), Anibal Palacio e Carlos Franco (oggi capo dell’ufficio
dei diritti umani di Alvaro Uribe)- la smobilitazione, la svendita e la
consegna di quell’organizzazione rivoluzionaria.
Una
volta realizzata la sua missione smobilitatrice e diventato portavoce
di “Esperanza, Paz y Libertad” (EPL), alleato con i paramilitari Fidel
e Carlos Castaño Gil e forte dell’appoggio economico delle corporazioni
delle banane e degli allevatori, fondò i cosiddetti “Comandos
Populares”, gruppi di assassini prezzolati che ebbero come prerogativa
lo sterminio fisico dell’opposizione e la “pulizia” della zona di
Urabá, funzionale all’implementazione di megaprogetti economici delle
transnazionali delle banane, dei grandi allevatori e dei latifondisti.
La
mattina del 26 ottobre 1991, nel chiosco all’entrata della famosa
tenuta “Las Tangas”, Bernardo Gutiérrez Zuluaga (EPL) e Fidel Castaño
Gil (AUCC), uno dei fondatori paramilitari in Colombia, si strinsero la
mano e siglarono un patto criminale.
Da quel momento in poi i paramilitari delle AUC, i Comandos Populares (smobilitati dell’EPL) e le cooperative Convivir
(fondate da Alvaro Uribe), tutti addestrati e coordinati dalle forze
militari e di polizia e finanziati dalle transnazionali delle banane
(come la statunitense Chiquita Brands) e dai latifondisti, si
dedicarono allo sterminio di militanti della sinistra e di leaders
contadini e sindacali, trasformando l’Urabá e Córdoba in un laboratorio
della morte che è costato la vita a centinaia e lo sfollamento a
migliaia e migliaia di persone, nonché l’appropriazione delle terre
abbandonate dai contadini a colpi di omicidi, minacce e terrore di
Stato.
Tutto ciò fu conosciuto come Plan Retorno
ed Operación Génesis,
ossia il famoso piano di “pacificazione” della regione coordinato e
sviluppato dal Generale Rito Alejo del Río, criminale di guerra
colombiano, di concerto con Fernando Millán, altro Generale assassino. Bernardo
Gutiérrez Zuluaga, promotore della formula del “pareggio negativo” (la
smobilitazione popolare come unica via), ha beneficiato della relativa
ricompensa prima come osservatore all’Assemblea Costituente del 1991 e
senatore dell’AD-M19, e poi come primo segretario all’ambasciata
colombiana nei Paesi Bassi e Rappresentante Permanente Aggiunto a Roma
alla FAO, finendo per sistemarsi in Italia alla direzione del Polo, in
cui si mascherava da uomo di pace.
Per la verità, la giustizia ed il risarcimento, né perdono né oblio, la soluzione è la giustizia popolare!
UNITA’ INVESTIGATIVA POPOLARE BOLIVARIANA (UIPB)
25 febbraio 2008, barricate e montagne della Nuova Colombia
COLOMBIA: URIBE CONTINUA AD ORDINARE DI ASSASSINARE SINDACALISTI!
Continuiamo
ad alzare la voce di denuncia e condanna dello sterminio del movimento
sindacale perpetrato con diverse modalità, in particolar modo lo
sterminio fisico. Inoltre, esigiamo al governo nazionale,
dipartimentale e distrettuale di investigare e fare luce sui fatti.Comunicato della Centrale Unitaria dei Lavoratori (CUT)
La
Centrale Unitaria
dei Lavoratori della Colombia (CUT) denuncia all’opinione pubblica
nazionale ed internazionale, attraverso il proprio Dipartimento dei
Diritti Umani e Solidarietà, i seguenti fatti accaduti a partire dalla
realizzazione della marcia “Per la Dignità delle Vittime”:
Gli
incessanti attacchi, minacce e persecuzioni contro dirigenti sindacali
e difensori dei diritti umani (chiamate telefoniche, sms, e-mail).
L’attentato
ai danni del compagno Rafael Boada, Presidente dell’Unione Nazionale
degli Impiegati Bancari (UNEB) sezione Bucaramanga, avvenuto il 7 marzo
scorso con spari effettuati da individui che si muovevano su una moto e
che hanno impattato il parabrezza del veicolo del compagno Boada.
L’assassinio della compagna Carmen Cecilia Carvajal Ramírez, docente
dell’istituto Normal Superior
del municipio di Ocaña (Dipartimento del Norte de Santander) ed
iscritta al sindacato ASINORT, avvenuto il 4 marzo scorso mentre si
apprestava ad andare al lavoro.
L’assassinio
del compagno Leonidas Gómez Rozo, dirigente nazionale dell’Unione
Nazionale degli Impiegati Bancari, membro del Gruppo Nazionale di
Educazione della CUT e della direzione del POLO nel distretto di
Bogotá. Il compagno Leonidas era scomparso il 5 marzo scorso, per
essere poi trovato dai suoi familiari e compagni il giorno 8 marzo,
brutalmente assassinato, nel suo appartamento.
L’assassinio
del compagno Gildardo Antonio Gómez Alzate, professore e delegato
dell’Associazione degli Istitutori di Antioquia (ADIDA) e membro del
Centro Studi e Ricerche Docenti (CEID), ucciso la sera dello scorso
sabato 7 marzo.
Al momento della stesura di questa denuncia, purtroppo, i sindacalisti assassinati nel corso di quest’anno sono 9. Esprimiamo le condoglianze e la solidarietà alle famiglie ed alle organizzazioni in lutto.
Domingo Tovar Arrieta Direttore del Dipartimento Diritti Umani e Solidarietà della CUT
|
|