Intervista a Michel Warschawski
Geraldina Colotti
Raggiungiamo a Gerusalemme l’analista
politico Michel Warschawski, 57 anni, uno dei maggiori esponenti
della sinistra radicale israeliana.
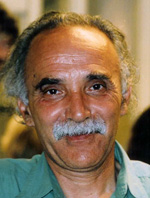
D. Lei è stato fra i primi
israeliani a rifiutarsi di prestare servizio militare fuori dai
confini e per questo, durante la guerra in Libano dell’82 è
stato più volte in carcere. Qual è la sua analisi oggi?
R. Non si può comprendere questa
guerra d’aggressione contro il Libano, né l’accanimento
contro i palestinesi, in particolare a Gaza, fuori dal contesto della
guerra permanente e preventiva intentata dai neoconservatori di
Washington a livello mondiale e fatta propria da Tel Aviv.
L’obiettivo è quello di imporre l’egemonia nordamericana
nella regione a scapito di regimi come Siria e Iran e organizzazioni
politiche di massa come Hamas e Hezbollah, identificate come
terroristiche. Ma questa guerra è stata anche un laboratorio,
in termini di strategia, tattica, e sperimentazioni di armi che
Israele ha ricevuto in questi anni da Washington: anche armi
sconosciute, come abbiamo appreso dal manifesto.
D. Nell’82, in Israele ci fu un forte
movimento di opposizione alla guerra. Qual è invece la
situazione oggi?
R. Anche oggi il movimento contro la
guerra è attivo, ma purtroppo è minoritario, non riesce
a esercitare egemonia. Al massimo mobilita 5-6.000 persone. Al suo
interno, ci sono forze di sinistra o di estrema sinistra. La
maggioranza ha meno di 25 anni. Sono quelli che si sono mobilitati
nel corso di questi ultimi anni contro l’occupazione, che non hanno
creduto alla propaganda secondo cui il processo di pace sarebbe
fallito per colpa del ‘terrorismo palestinese’, che hanno
compreso la strategia di neocolonizzazione messa in atto dal governo.
Sono quelli che si sono opposti alla costruzione del muro, alla
repressione nei territori occupati, e che oggi costituiscono la
colonna vertebrale del movimento antiguerra. Ma fra questi giovani e
la mia generazione, quella dei militanti che si sono opposti alla
guerra in Libano nell’82, c’è un buco generazionale. Il
movimento contro la guerra, che era riuscito a farsi sentire davvero
nell’82 e anche nell’88, durante la prima intifada, in gran parte
oggi sostiene ufficialmente la politica del governo: sostiene quella
che percepisce come una guerra di autodifesa. Il discorso secondo cui
c’è una minaccia del terrorismo islamico che incombe sulla
democrazia, è ormai maggioritario, ha distrutto quella grande
opposizione alla guerra, la sua efficacia e la sua capacità di
produrre egemonia in Israele. Oggi la maggioranza della società
vede nell’esercito l’ultima difesa contro un nuovo giudeocidio.
Alcune delle unità combattenti più prestigiose,
assomigliano ormai agli squadroni della morte, specializzati come
sono nelle cosiddette uccisioni mirate, ma la domanda per entrare a
farne parte è altissima.
D. Perché la società
israeliana ha voltato le spalle alla pace? Le rivolgo una domanda che
ricorre nei suoi ultimi libri: Sulla frontiera, edito da Città
aperta; Israele-palestina, edito da Sapere 2000; A precipizio,
Bollati Boringhieri…
R. Da anni è in corso in Israele
una massiccia campagna per convincere la società che la pace è
un’illusione e che occorre tornare al cosiddetto spirito del ’48.
Una vera controriforma su tutti i piani (culturale, ideologica,
giuridica e istituzionale), che, dopo l’11 settembre, ha incontrato
e inglobato la teoria dello scontro di civiltà e la retorica
della guerra al terrorismo. Alle ragioni geostrategiche di controllo
del territorio e di annessione continua dell’intera Palestina
storica, si è aggiunto un altro elemento: a partire dell’11
settembre, anche la stragrande maggioranza della sinistra moderata,
quello che per voi è il centrosinistra, pensa che ci sia una
civiltà minacciata dai barbari e che occorra difendersi. Si
crede l’avamposto della civilizzazione nel cuore del mondo arabo,
l’ultimo baluardo in seno alla barbarie: questo è il
discorso che è passato.
D. E non riscontra un atteggiamento
speculare anche in certi settori dell’islamismo radicale?
R. Non sono d’accordo. Ascolto con
molta attenzione Nasrallah e, come altri commentatori in Israele,
constato che i suoi discorsi sono pacati e di grande responsabilità:
tutto il contrario dell’occidente che si pretende baluardo di
civiltà e che invece trasuda retorica fondamentalista. Sembra
di assistere a un capovolgimento di valori: il campo laico che si
abbandona al fanatismo, e quello religioso che, anche se parte da una
diversa concezione, fa di tutto per non pronunciare discorsi
confessionali.
D. Nei suoi libri lei parla di
disumanizzazione dei palestinesi e degli arabi da parte di Israele.
Cosa intende?
R. Con l’11 settembre c’è
stata una svolta. Fino ad allora, i palestinesi venivano percepiti
come nemici con cui si aveva una divergenza profonda, soprattutto per
via della violenza, ma si dava per possibile che la questione potesse
essere affrontata, che si dovesse arrivare a una qualche trattativa
concreta. Aver assunto il discorso dei neoconservatori americani, ha
spinto Israele a un cambiamento qualitativo: da nemici che erano, i
palestinesi si sono trasformati in minaccia. E una minaccia non è
più identificabile in un contenzioso concreto e in un nemico
concreto, incombe e basta e ci si deve difendere. “Israele è
una villa nel cuore della giungla”, ha detto qualche anno fa Ehud
Barak. Si può mai intrattenere rapporti con la giungla? Questo
discorso domina e guida la politica israeliana e la gran parte
dell’opinione pubblica.
D. Scomparsa l’Unione sovietica, si
ha bisogno di un altro Impero del male?
R. E’ evidente che con la scomparsa
del nemico globale che minacciava il cosiddetto mondo libero, e cioè
l’Urss, e con l’azzeramento del processo di pace con i
palestinesi, si è dovuto rimpiazzare il vuoto con una minaccia
apocalittica. Non a caso, riferendosi ad Al-Qaeda si parla di
nebulosa: un mostro immateriale. Una guerra, quindi, che non si può
mai vincere perché il nemico è un fantasma che non può
essere identificato. Solo che la guerra è reale e fa disastri
concreti. Anzi, innesca un meccanismo difficilmente controllabile,
capace di creare da sé la minaccia ancora prima che si
presenti. In Israele, questo meccanismo si innerva su un inconscio
collettivo marcato da un genocidio che è ancora recente,
perché sono passati appena 60 anni, e che rapidamente traduce
ogni problema politico concreto in minaccia esistenziale. Non è
infatti razionale credere che qualche razzo di Hezbollah possa
preoccupare davvero una grande potenza militare come Israele, al
massimo può portare a un certo livello di destabilizzazione,
ma certo non minaccia l’esistenza del popolo ebreo come ha
sostenuto il primo ministro israeliano. Però, la propaganda
porta a leggere il presente e la storia come un immenso pogrom che
continua da millenni e per cui non ci si può mai fermare: una
dinamica di guerra infinita. Siamo sull’orlo del baratro e ne
stiamo avendo un assaggio.
D. Il suo libro A precipizio, La crisi
della società israeliana, è dedicato a due comunisti
tedeschi, trasferitisi in Israele per fuggire al nazismo. Due
militanti anticolonialisti. Perché ha fallito quella
generazione di comunisti in Israele?
R. Micha e Trude hanno trovato rifugio
in Palestina un po’ loro malgrado, pensavano di tornare indietro
dopo la liberazione dal nazifascismo, ma poi sono rimasti. Da loro,
impermeabili a ogni forma di trialismo, ho appreso che
l’internazionalismo e l’impegno comunista sono maniere di essere
cittadini del mondo. Erano migliaia i comunisti che, prima del ’48,
si sono scontrati con una realtà coloniale che gli ha lasciato
poco spazio: non erano aggrappati all’identità ebraica, ma
non erano arabi. E gli arabi, anzi, li identificavano col campo
avverso. E’ la logica perversa dei conflitti nazionali. Ti ritrovi
tuo malgrado nei quartieri bombardati dagli arabi, o viceversa: ci
vuole una grande convinzione per prendersi le bombe e dire: io sono
altro da questo.
D. Lei pensa in questo modo, ma
continua a vivere a Gerusalemme. Perché?
R. Ancora di recente, durante una
manifestazione contro la guerra, sono stato aggredito dagli
estremisti religiosi. Ma ogni cedimento sarebbe una tragedia per i
nostri figli. La politica di guerra dei dirigenti israeliani porta
alla catastrofe, e chiude le porte alla possibilità di una
coesistenza nazionale con i palestinesi. Ci fanno odiare dagli arabi
perché, pur vivendo in una regione araba, Israele rigetta il
mondo arabo. Bisogna essere pazzi per credere che possiamo imporre la
nostra esistenza in questa regione e contro il mondo arabo.
D. In un volume edito da Sapere 2000,
Israele-Palestina, la sfida binazionale, lei – riferendosi a
lontane esperienze intercomunitarie tra ebrei e musulmani, auspica un
nuovo sogno Andaluso per il XXI secolo. Che cosa intende?
R. Una comunità può
vivere e pensarsi in relazione con l’ambiente umano che la
circonda, oppure in autarchia. Io penso che tutto ciò che è
autarchico impedisca ogni sviluppo e marcisca. Accade così a
Israele, che ha scelto di vivere in autarchia, in una specie di
ghetto armato in pieno Medioriente, cioè in opposizione al
contesto. Uno dei compiti degli intellettuali – che oggi,
purtroppo, sono completamente preda della sindrome da assedio - è
di far capire questo alla gioventù israeliana, insegnare nelle
scuole che le più belle pagine degli ebrei nel mondo sono
quelle in cui hanno arricchito e si sono arricchiti della cultura del
posto. In particolare, in Andalusia, in quella che chiamiamo l’età
d’oro degli ebrei, quando la cultura musulmana e quella ebraica, e
in misura minore quella cristiana, convivevano in un dialogo proficuo
che ha portato al massimo sviluppo il Medioevo. E’ stata poi la
Riconquista che, dopo la caduta di Granada nel 1487 ha distrutto
tutto. Le pagine di questa storia non si insegnano in Israele, farle
conoscere, invece, serve a dimostrare che la convivenza tra giudei e
musulmani è stata possibile e reciprocamente feconda.
D. Cosa dovrebbe fare Israele per
invertire la rotta?
R. Intanto, applicare le numerose
risoluzioni dell’Onu, tutte disattese. Mettere fine
all’occupazione. Costruire legami di coesistenza con i palestinesi
e con la regione in cui si trova, non fare l’apripista per le
politiche nordamericane. Sul piano politico, dovrebbe trasformarsi da
stato ebraico a stato di tutti i cittadini, separare religione e
Stato, statalizzare la terra e finirla con le discriminazioni
etniche. Sostituire la Legge del ritorno con una legislazione che
consenta il ricongiungimento familiare e l’immigrazione di tutti, a
cominciare dai profughi palestinesi. Prevedere forme di autogestione
che garantiscano l’espressione delle diversità, in primo
luogo quella dei palestinesi.
D. Nei suoi libri, lei paragona il
processo di Oslo a una sorta di compromesso storico che non ha
funzionato. Quale via rimane oggi ai palestinesi?
R. Siamo in un complicato periodo di
transizione. Se mi avesse posto la domanda qualche anno fa le avrei
detto: qualunque sia la soluzione a lungo termine, a breve termine,
deve passare per la costruzione di uno stato palestinese e la fine
dell’occupazione, la decolonizzazione della Cisgiordania, uno stato
palestinese a fianco di quello israeliano, e un lavoro per arrivare a
una forma di coabitazione più stretta. Ma ora, dopo la
distruzione sistematica nei territori occupati, che da cinque anni
Israele persegue, e l’accanimento degli ultimi mesi contro il
popolo palestinese, ho molte difficoltà a rispondere. Cosa fa
la l’Europa perché i palestinesi abbiano una terra? Cosa fa
l’Italia ora che c’è un governo di centrosinistra? Molto
meno di quanto facevano i governi democristiani. Per ora, quindi,
vedo un unilateralismo totale che mira a chiudere la partita con una
seconda nakba. Secondo la politica dello stato israeliano, esiste un
solo popolo, quello ebreo, e un problema: quello palestinese.